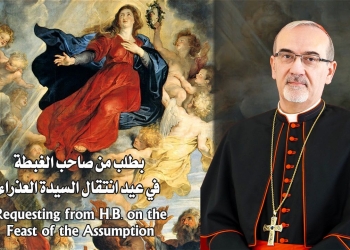Conferenza a Santiago de Compostela - 7 ottobre 2022
7° Congresso mondiale sulla pastorale del turismo
1. Homo viator
Il pellegrinaggio è un’esigenza antropologica profonda dell’uomo che si radica nel suo costante bisogno di essere alla ricerca di un luogo. Egli sperimenta, in varie forme, di essere esistenzialmente “fuori luogo”, precario, itinerante in questo mondo, in altre parole: lontano dalla piena felicità. Assetato di assoluto, nomade inquieto, turista della verità, perenne itinerante verso l’Oltre, non si ferma mai davanti ai suoi limiti, essendo in continua ricerca della piena realizzazione della sua esistenza: egli è per essenza homo viator[1]. In questo senso, il pellegrinaggio è antico quanto l’uomo e scaturisce dalla sua religiosità naturale: da sempre vi sono luoghi ritenuti speciali, quasi ponti tra cielo e terra. Il luogo santo è, sin dall’origine, axis mundi, porta al numinoso, ove ci si reca in cerca di sicurezza, per ricevere risposte o impetrare grazie da forze superiori e celesti.
Se è vero, da una parte, quanto affermato lapidariamente da B. Pascal: «Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre»[2], è certo, dall’altra, che l’uomo, cosciente di abitare in una tenda provvisoria e precaria, è alla ricerca della sua vera patria. L’inquietudine che lo spinge verso l’Altro da sé è, in fondo, il suo “motore esistenziale”.
Nella festa ebraica di Sukkòt (“Tende” o “Capanne”) ogni famiglia ebrea deve adempiere la mitzvàh, il “precetto”, di costruire una sukkàh, una “tenda” all’aperto, il cui tetto dev’essere di palmizi, in modo da contemplare le stelle. In questa ricorrenza si fa zikkaròn, “memoriale”, del peregrinare del popolo nel deserto. La forza del memoriale è tutta nell’attualizzazione: un ebreo non può dimenticare di esser sempre pellegrino sulla terra e deve rivivere ogni anno quella primordiale esperienza di pellegrinaggio nel deserto. Noto tra parentesi che da noi vi sono alcuni beduini arabi, ormai sedentarizzati, che amano passare di tanto in tanto un breve periodo nelle tende per non dimenticare le loro radici!
2. Deus viator per l’homo viator
La rivelazione divina s’innesta su questa ricerca naturale, antropologica e religiosa dell’uomo, rinnovandola e trasfigurandola. Il filosofo ebreo E. Lévinas ha magistralmente individuato la differenza tra la mentalità greca e quella ebraica nella radicale diversità tra il peregrinare di Ulisse e quello di Abramo. Il primo è sì un viaggio verso l’ignoto e l’altro da sé, ma che alla fine ritorna alla propria patria, alla sua famiglia e al Sé: è ciclico. Il secondo è totalmente aperto: Abramo «lascia per sempre la sua patria per una terra ancora ignota e […] interdice al suo servo persino di ricondurre suo figlio al punto di partenza»[3]. Per questo Dio chiama Abramo al pellegrinaggio della fede con queste testuali parole: «Vattene (lekh lekhà) dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti mostrerò» (Gen 12,1).
Nella tradizione biblica recarsi in pellegrinaggio significa – secondo la frase che si ripete come un ritornello nel Deuteronomio – verso il «luogo che il Signore avrà scelto»[4]. Forse è proprio per questo che tale luogo rimane anonimo: non si tratta solo di un luogo fisico, ma di un andare verso il Signore! Non a caso, secondo la tradizione ebraica il primo “luogo santo” è Dio stesso. Sin da tempi antichi, il tempio di Gerusalemme, luogo della dimora di Dio nel mondo, era chiamato semplicemente ha-maqòm, “il luogo”[5], che poi nella letteratura rabbinica sarà un espressione per designare Dio stesso, “il Luogo” per eccellenza[6], come afferma Filone di Alessandria (†45 d.C. ca.): «Dio stesso è denominato “luogo” (autos ho theos kaleitai topos), perché contiene il tutto senza esser assolutamente contenuto da nulla ed è il rifugio di tutto, e perché è il suo proprio luogo, essendo contenuto in se stesso e sviluppato da lui solo»[7].
D’altra parte Dio, pur chiamando l’uomo al pellegrinaggio più ardito possibile – il viaggio perennemente e dinamicamente aperto verso l’Infinito che è lui stesso! – è tutt’altro che lontano. Oggi si discute molto – non senza polemica – se Gesù sia stato un migrante o meno. In realtà, già nella prima alleanza, Dio ha fatto molto di più. Abitando in una tenda in mezzo al popolo peregrinante nel deserto, si è fatto pellegrino con il popolo, nomade, itinerante, Deus viator per l’homo viator. Egli è la prima vera guida dei pellegrini! Già nell’Antico Testamento, pertanto, Dio è nel contempo guida del popolo e sua meta, suo vero luogo. Ciò si compirà pienamente in Cristo, il Viandante e al tempo stesso “il Luogo” per antonomasia, il Tempio fatto carne.
3. Peregrinare verso il volto di Dio
Com’è noto, il pellegrinaggio è fondamentale nella fede ebraica (come poi in quella musulmana) e lo era in modo particolare all’epoca di Gesù, quando il tempio era ancora in piedi. La stessa Toràh, in Dt 16,16, prescrive il pellegrinaggio a Gerusalemme in occasione delle feste annuali di Sukkòt, Pèsaḥ e Shavu‘òt, con queste letterali parole: «Tre volte all’anno ogni tuo maschio sarà visto con il Signore, tuo Dio [tradotto usualmente “si presenterà davanti al Signore, tuo Dio”, ndr], nel luogo che egli avrà scelto». Tale frase è in realtà un’interpretazione posteriore di scribi del VII-VIII secolo d.C., i masoreti, i quali aggiunsero al testo ebraico, originariamente solo consonantico, le vocali. In realtà, il testo consonantico recita letteralmente: «Ogni tuo maschio vedrà (yir’èh) il volto del Signore» (cf. Es 23,17). I masoreti, attenti a evitare l’antropomorfismo, non hanno voluto che il lettore intendesse male ciò che in realtà il testo afferma chiaramente: il pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme equivale addirittura a «vedere il volto del Signore».
Sin da tempi antichi, infatti, il tempio di Gerusalemme era considerato il centro della terra e la porta del cielo, l’axis mundi, l’ombelico del mondo[8], come scrive, già prima dell’era cristiana, l’autore del Libro dei Giubilei: «Il giardino dell’Eden è il Santo dei Santi e la dimora del Signore, il monte Sinai è il centro del deserto, il monte Sion è il centro dell’ombelico della terra: questi tre luoghi furono creati come luoghi santi, l’uno innanzi all’altro»[9]. Il Midrash Tanḥuma esplicita tale tradizione: «Come l’ombelico è situato al centro dell’essere umano, così la terra d’Israele è situata al centro del mondo […]. La terra d’Israele risiede al centro del mondo, Gerusalemme al centro della terra d’Israele, l’area del tempio al centro di Gerusalemme, il santuario al centro dell’area del tempio, l’arca al centro del santuario e la pietra di fondazione, dalla quale fu fondato tutto il mondo, davanti all’arca»[10].
Il tempio di Gerusalemme è quindi ritenuto, sulla linea del sogno di Giacobbe in Gen 28, il «luogo» per eccellenza (v. 10: «[Giacobbe] s’imbatté nel luogo»), la «pietra» di fondazione del mondo (cf. v. 11), la scala (sullàm) tra cielo e terra su cui sta Yhwh (vv. 12-13), la «porta del cielo» (v. 17), la «casa di Dio» (bet-èl, v. 19). Il Santo dei Santi era considerato il luogo posto in corrispondenza del giardino dell’Eden, il ponte tra la Gerusalemme terrestre e quella celeste.
Com’è noto, i primi giudeo-cristiani ripresero tale tradizione, trasferendo il centro della terra al monte Golgota. Nella versione araba dell’apocrifo Caverna dei Tesori si comanda ad Adamo che si faccia seppellire nel luogo della morte e della risurrezione di Cristo: «Il luogo in cui sarà deposto il tuo corpo è il centro della terra, dal quale e nel quale la salvezza verrà a te e a tutti i tuoi figli (…). Adamo chiamò quella grotta “caverna dei tesori”»[11]. Anche Origene conferma tale tradizione nel suo Commentario a Matteo (ca. 245 d.C.): «Il corpo del primo uomo fu sepolto nel medesimo luogo in cui Cristo fu crocifisso, affinché come tutti muoiono in Adamo tutti ricevano la vita in Cristo (cf. 1Cor 15,22)»[12]. Si tratta di una fine interpretazione: nel luogo in cui Adamo è disceso nella tomba, Cristo, nuovo Adamo, è morto ed è disceso per vivificare il primo uomo.
4. Yerushalàim: la “dualità” di Gerusalemme
Lo stesso nome ebraico di Gerusalemme, Yerushalàim, è quanto mai evocativo. Tralasciando la sua etimologia scientifica, esso è grammaticalmente una forma duale, come a indicare che vi sono due Gerusalemme: una terrestre, l’altra celeste. Non a caso, il libro dell’Apocalisse si chiude con la meravigliosa visione della Gerusalemme che scende dal cielo (cc. 21-22): essa è la «tenda di Dio con gli uomini» (21,3) che compie il peregrinare di Dio nella tenda con gli Israeliti nel deserto, ha «dodici porte» aperte verso i quattro punti cardinali perché è la metropoli cosmopolita per eccellenza (21,12-13), è il nuovo Eden (22,1-2). Ecco la meta di ogni nostro pellegrinaggio!
Si spiega così come il pellegrinaggio in Terra Santa, che ha le sue radici nell’ebraismo, si sviluppò nella Chiesa fin dai primi secoli non solo come pratica devozionale, ma anche e soprattutto come un ritorno alle sorgenti della fede, soprattutto alla Scrittura e alla storicità della rivelazione (cf. Melitone da Sardi, S. Alessandro di Cappadocia [o di Gerusalemme], Origene, S. Pionio di Smirne, Eusebio di Cesarea, S. Girolamo); come un contatto vivo con la liturgia madre della Chiesa di Gerusalemme (Egeria), con il monachesimo (S. Giovanni Cassiano, S. Girolamo, Cirillo di Scitopoli, Giovanni Mosco) e con la Gerusalemme cristiana cosmopolita[13]; come un rinnovamento del catecumenato e un cammino penitenziale (soprattutto nel Medioevo).
5. I cristiani di Terra Santa, cittadini delle “due Gerusalemme”
Ci siamo forse dimenticati, presi dall’appassionata esposizione dello sfondo delineato, dei cristiani di Terra Santa? Giammai! Anzi, mediante quella abbiamo forse già sondato la profondità della loro identità, del mirabile paradosso in cui vivono e che costituisce la loro “croce e delizia”: essere sospesi tra le due Gerusalemme, celeste e terrestre. Nati dove «tutti siamo nati» e in cui «sono le tutte le nostre sorgenti» (Sal 87,5.7), i nostri cristiani sono spesso stranieri nella propria terra. Cresciuti nella chiesa madre di Gerusalemme, nutriti e sostenuti dalla Chiesa universale, si sentono sovente al suo margine. Giustamente fieri di essere nativi dei luoghi santi, disconoscono in vari casi la pratica della fede. Sono arabi, ma non musulmani. Sono palestinesi, eppure non fautori di uno stato islamico. Portano la croce di Cristo sulle loro case, sul loro petto e spesso in un tatuaggio sulla loro carne, ma talora gli antepongono Barabba, cioè la ricerca di una mera giustizia umana (ma chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha mai scelto Barabba?)[14]. Parecchi cristiani sono israeliani, ma non ebrei: è il caso dei cristiani arabo-israeliani, di quelli di lingua ebraica e dei numerosi migranti. Per complicare ancora di più le cose, la gran parte dei fedeli di Terra Santa è cristiana, ma non cattolica (per lo più è ortodossa), mentre la maggioranza dei cattolici non è di rito latino, ma orientale! Si pensi che in arabo i greci ortodossi sono chiamati rum ortodòx (“romani ortodossi”) e i greco cattolici rum katolìk (“romano cattolici”)! Potremmo facilmente allungare la lista dei paradossi vissuti dai nostri fedeli, ma questi siano sufficienti per avere immenso rispetto del loro valore – hanno custodito la fede per secoli in messo a una maggioranza non cristiana! – e delle loro ferite, per amarli come fratelli, correggendoli se necessario, ma non prima di averne apprezzato l’importanza.
Tutto ciò, inoltre, rende affini i nostri fedeli ai pellegrini e, in fondo, a tutti gli uomini: anch’essi sono precari o comunque si sentono in molti casi stranieri nella propria terra, non identificandosi sic et simpliciter con uno stato ebraico o a maggioranza musulmana, seppur cercando di vivere in pace e di essere buoni cittadini. Insomma, i nostri fedeli di Terra Santa sono più che mai chiamati ad accettare la realtà – mirabile e paradossale al tempo stesso – che contraddistinse i primi cristiani, secondo quanto riferisce riguardo a loro la Lettera a Diogneto (5,5): «Essi abitano la propria patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come stranieri; ogni terra straniera è patria per loro e ogni patria terra straniera».
Nel testo riportato sopra, abbiamo reso con “forestieri” il termine greco pàroikoi. Il termine “parrocchia” deriva esattamente dal greco paroikìa, che può significare sia una realtà “vicina alla casa”, sia una realtà che, essendo vicina ad essa, è “fuori della casa”. Uno dei segni di tempi che dobbiamo rilevare è precisamente il fatto che la parrocchia, tanto “vicino a casa” in un ambiente di cristianità, è ormai sempre più “fuori casa”, sempre più pellegrina nel mondo. Stiamo tornando, infatti, a tempi analoghi a quelli della Chiesa apostolica, in cui i cristiani erano una minoranza in mezzo a un mondo pagano. In esso, la Chiesa è sempre più chiamata a essere sale, luce e lievito, cercando di evitare i due estremi opposti: piangere su stessa da una parte, ostinarsi nel restaurare la cristianità dei bei tempi passati dall’altra.
La Chiesa cattolica, in questo contesto così particolare, è numericamente piccola (circa l’1% del totale della popolazione), ma ricca di tante iniziative e istituzioni. Sono oltre un centinaio le scuole cattoliche, numerosi anche i centri di studio biblici e teologici, le case di accoglienza, le case di sostegno alle diverse forme di fragilità (ospedali, case per disabili, orfanotrofi, ecc.). I sacerdoti diocesani, tutti locali sono oltre un centinaio. Accanto a loro vi sono circa seicento religiosi e circa un migliaio di religiose, il cui servizio è particolarmente prezioso ed apprezzato. La Chiesa di Terra Santa è la Chiesa dei Luoghi Santi, ben conosciuti e punto di riferimento centrale per l’identità cristiana delle nostre comunità e di tutto il paese. Ma non si possono separare i Luoghi santi dalle comunità ecclesiali che intorno ad esse vivono e dalle istituzioni che nel tempo le comunità hanno creato.
L'identità della comunità cristiana non è legata solo ai singoli siti o monumenti, come se questi potessero essere separati gli uni dagli altri o isolati dalle rispettive comunità. L’identità cristiana delle comunità di Terra Santa è si incentrata sui suoi luoghi santi, ma ruota anche attorno alle loro scuole, ospedali, attività culturali, sociali ed economiche. Non si possono insomma separare i Luoghi, dalle persone e dalla vita ordinaria delle persone.
Il pellegrinaggio in Terra Santa e a Gerusalemme in particolare deve si essere un ritorno alle sorgenti della nostra fede ed un incontro con l’umanità di Cristo e la storicità della rivelazione divina, ma deve anche diventare un incontro con quella piccola porzione di Chiesa che in quei luoghi tiene viva la testimonianza cristiana.
I cristiani locali, in conclusione, seppur segnati da conflitti e sofferenze continue, si trovano in una situazione privilegiata che dovrebbero vivere anche tutti i cristiani: quella di essere «stranieri e pellegrini» in questa terra (Eb 11,13; 1Pt 2,11). Questo ovviamente non vuol dire non lottare perché i cristiani locali possano avere una patria, una vita dignitosa e tranquilla, una società giusta e senza discriminazioni di sorta. Significa invece aderire alla chiamata che nostro Signore ci ha fatto in primis in questa Terra Santa – già a quei tempi piena di conflitti, congiure, usurpazioni di terre, ingiustizie sociali e religiose – di essere sale, luce e lievito del mondo. L’importante non è che vi sia molto sale in una pietanza, ma che il poco sale che vi sia, non perda il sapore e sali veramente. Non tutto deve essere luce in questo mondo, ma è sufficiente una piccola luce, ma che brilli veramente. Non è necessario mettere molto lievito nella pasta: ne basta poco se esso fermenta realmente.
Ciò vuol dire che per i cristiani di Terra Santa è quanto mai necessario ritornare alle sorgenti della loro fede, essere fedeli alla parola e alla grazia di Gesù Cristo, ripercorrere il pellegrinaggio della fede. Occorre quindi ritornare alla radicalità della vita cristiana, che non è mai fondamentalismo: “radicalità” significa tornare alle radici del nostro Battesimo e della nostra fede, alla novità di Cristo, al cuore del Vangelo che è il Discorso della Montagna e quindi all’amore ai nemici, al centro della nostra identità cristiana che è il mistero pasquale di Cristo, alla natura divina che egli ci ha donato per mezzo del suo Spirito e che ci fa nuove creature, capaci di amare oltre la morte.
Gerusalemme, infine, è uno specchio di ciò che noi tutti siamo. Non dobbiamo scandalizzarci delle sue ferite, delle sue contraddizioni e nemmeno dei suoi peccati. Il pellegrino “neofita”, al vedere le divisioni e i peccati di Gerusalemme, resta turbato: basta che entri nel Santo Sepolcro! Il pellegrino “iniziato”, invece, sa che la “dualità” di Gerusalemme – terrestre e celeste – è anche la sua. Anche noi siamo, come la Gerusalemme di quaggiù, pieni di caos, contraddizioni, ingiustizie fatte e subite, luoghi di mercato, ecc… Eppure è questa la Gerusalemme concreta che Dio ha eletto, come ha scelto noi, per trasfigurarci dalle nostre ferite e manifestare in noi la Gerusalemme celeste, affinché diventiamo, in questa nostra “tenda” debole e precaria, tempio vivo dello Spirito Santo, dimora di Dio tra gli uomini, ponte tra cielo e terra, tra la Gerusalemme di quaggiù e quella di lassù, «che è libera ed è la madre di tutti noi» (Gal 4,26).
[1] Cf. G. Marcel, Homo viator. Prolegomeni ad una metafisica della speranza, Torino 1967.
[2] B. Pascal, Pensées, n. 205 [139], in J. Chevalier (ed.), L’oeuvre de Pascal, Paris 1936, 875: «Tutta l’infelicità dell’uomo viene da una sola cosa, non saper starsene quieto, in una stanza» (trad. nostra).
[3] E. Lévinas, «La traccia dell’altro», in Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, Milano 1998, 219.
[4] Cf. Dt 12,5.11.14.18.21.26; 14,25; 15,20; 16,2.6-7.11; 17,8.10; 18,6; 26,2.
[5] Così in 1Re 8,29; Esd 5,15; 2Mac 1,29; 2,18; 3,2; 8,27; 13,24.
[6] Cf. A. Marmorstein, The Old Rabbinic Doctrine of God, I. The Names and Attributes of God (PJC 10), London 1927, 92; E.E. Urbach, The Sages. Their Concepts and Beliefs, I, Jerusalem 1975, 63-79.
[7] Filone, Som 1,61-63 (trad. nostra).
[8] Già per i babilonesi Bab-Ilu (“Babilonia”), la “porta di Dio”, era il centro della terra, mentre per i greci l’omfalòs, l’“ombelico” del mondo, si trovava nella parte più interna del tempio di Apollo a Delfi.
[9] Jub 8,19 (trad. nostra). 1Hen 26,1-2 denomina la «santa montagna» e il «luogo benedetto» (con tutta probabilità il tempio di Gerusalemme) con l’espressione «centro della terra», mentre Giuseppe Flavio, Bell 3,52, attesta che Gerusalemme era chiamata «ombelico della terra» (cf. Ant 3,180-185), e Filone, LegGai 281.294; Flacc 46, la considera la «metròpolis», la «città madre» e «capitale del mondo».
[10] Cf. Tan Qedoshim 10 (trad. nostra); cf. b.San 37a.
[11] CavTes (vers. araba) 96a,11-14.16-18 (trad. nostra); 96b,7-8; cf. CavTes (Ms. Or) 5,10-11.
[12] Origene, Comm Mt 126.
[13] Egeria, Itin 47,3-4, ci informa che al S. Sepolcro la liturgia e la predicazione erano in greco, ma vi era un traduttore in siriaco (aramaico). Inoltre, benché dal 451 i Patriarchi di Gerusalemme fossero greci, la popolazione locale era mista: oltre a greci, vi erano arabi, siro-aramei, discendenti dei nabatei, dei samaritani, dei moabiti, ecc... Grazie al forte richiamo dei luoghi santi, molti pellegrini/e di varie etnie si erano definitivamente stabiliti in Terra Santa, e alcuni di essi divennero monaci/he. Sul monte degli Ulivi, ad es., vi erano monaci che pregavano in greco, georgiano, siriaco, armeno, latino e arabo!
[14] Cf. Conferenza in https://lpjold.media-clouds.net/it/latin-patriarch/perdono-possibile-cammini-di-riconciliazione.html
(https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-03/quo-049/il-perdono-possibile.html).