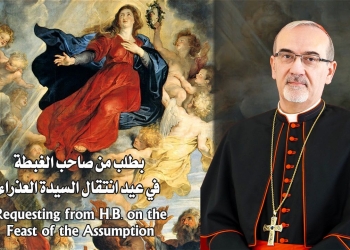Introduzione
Grazie del vostro invito, che mi onora. Sono grato alla vostra venerabile istituzione, con la quale collaboriamo ormai da numerosi anni, grazie al fatto che ci è stata concessa l’affiliazione del nostro Studio Teologico del Patriarcato Latino di Gerusalemme con la Facoltà di Teologia. Ritengo questo legame tra Roma e Gerusalemme di fondamentale importanza per la Chiesa di oggi. Approfitto anche per rivolgere i miei migliori auguri al nuovo Rettore Magnifico, Mons. Amarante, al nuovo Prorettore, Mons. Ferri, e al nuovo Decano di Teologia, Mons. Lameri.
Quanto sta avvenendo in Terra Santa è una tragedia senza precedenti. Oltre alla gravità del contesto militare e politico, sempre più deteriorato, si sta deteriorando anche il contesto religioso e sociale. Il solco di divisione tra comunità, i pochi ma importanti contesti di convivenza interreligiosa e civile si stanno poco alla volta disgregando, con un atteggiamento di sfiducia che invece cresce ogni giorno di più. Un panorama desolante. Non mancano certo elementi di speranza, tra le tante persone che ancora oggi, nonostante tutto, vogliono lavorare per la riconciliazione e la pace. Ma dobbiamo realisticamente riconoscere che si tratta di realtà di nicchia e che il quadro generale resta molto preoccupante.
Questa tragedia, oltre a legarmi ancor più al gregge di cui sono pastore, suscita in me innumerevoli riflessioni sulla pace. Si può ancora “pensare la pace” oggi, in Terra Santa? “Pace” sembra essere oggi una parola lontana, utopica e vuota di contenuto, se non oggetto di strumentalizzazione senza fine. Non di rado, gli stessi che sono a favore della pace terminano i loro discorsi dicendo che per giungervi è inevitabile la guerra.
La nostra terra è ancora sanguinante, la nostra gente in preda alla paura e all’incertezza del futuro. Molti, troppi, hanno di fronte a sé solo macerie.
Il tema che mi avete proposto per questa lectio – caratteri e criteri per una pastorale della pace - potrà essere solo sommariamente presentato in questa sede, senza intenti esaustivi. Il mio compito qui – come lo intendo io – non è quello di fare un discorso e proporre criteri generali per costruire contesti di pace, o concreti percorsi di pace possibile. I percorsi e i criteri, come sappiamo sono tanti: oltre a quelli religiosi, vi sono quelli economici, politici, sociali, mediatici, formativi. Sono strettamente connessi ai concetti di memoria, di identità e molto altro. Si tratta cioè di un tema assai ampio. Non sarà questo l’ambito della mia presentazione, ma sarà piuttosto una introduzione basata sulla mia esperienza di pastore in Terra Santa. Partendo, cioè dalla mia esperienza, cercherò di indicare alcuni criteri sui quali la Chiesa di Terra Santa dovrebbe fondare la sua azione di pace, in quello specifico contesto, oggi al centro dell’attenzione di tutto il mondo e fonte di divisione anche in molte altre parti del mondo.
- Guardare il volto di Dio
Prima di tutto penso sia importante chiarire perché la pace è un tema centrale per la vita della Chiesa, e per la sua azione nel mondo.
La prima peculiarità della pace è che essa, prima di essere un progetto umano conforme alla volontà divina, è un dono di Dio, anzi, dice qualcosa di Dio stesso: Adonài shalòm, «Il Signore è pace» (Gdc 6,24; cf. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 488). Com’è noto, l’ebraico shalòm – come del resto il suo corrispettivo arabo salàam – indica molto più di una situazione sociopolitica di assenza di guerra: esso esprime “pienezza di vita”, approccio integrale. Non è quindi solo una costruzione umana o un traguardo dell’umana convivenza, quanto piuttosto una realtà che viene da Dio e dalla relazione con lui: è il compimento delle promesse messianiche (cf. Is 2,2-5; 11,6-9). Gesù Cristo, il Messia è Sar shalòm, «Principe della Pace» (Is 9,5), è lui stesso «la nostra pace» (Ef 2,14), l’unico che ha abbattuto la barriera tra gli uomini, il muro d’inimicizia che era frammezzo (cf. Ef 2,14-16). Da Gerusalemme è risuonato il grido del Risorto che è giunto fino agli estremi confini della terra: «Pace a voi!» (Gv 20,19). Non a caso, è questa la prima parola del Risorto agli apostoli e alle donne riuniti nel Cenacolo e questa, come uomini nuovi e risorti, deve essere anche la nostra prima e ultima parola. Non è una “pace mondana” – dice Cristo – ma la «mia pace» (Gv 14,27). La «nostra pace» ci dona quindi la “sua pace”, poiché ci dona se stesso, morto e risorto per noi. Il cuore della pace è il mistero pasquale di Cristo. È proprio in virtù di questo mistero che la pace, che è Cristo, diviene nel contempo riconciliazione con Dio e tra gli uomini. Per tale ragione, e ciò va ribadito oggi con forza, ogni azione pastorale della Chiesa, come del resto ogni sua opera sociale, non può esser mai in nessun modo disgiunta dall’evangelizzazione (cf. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 493): l’annuncio del Vangelo è proclamazione del «vangelo della pace» (Ef 6,15) e chi evangelizza annuncia la pace anche ai nemici, proprio come fece Pietro a Cornelio, che era – e non bisognerebbe mai dimenticarlo di questi tempi! – centurione delle forze militari che occupavano la sua terra (cf. At 10,36).
Tale prima peculiarità, squisitamente teologica, della pace, ci fornisce il primo e basilare criterio per la pace: guardare il volto di Dio. Questo criterio è stato segnalato da San Paolo VI quando, mentre era impegnato a concludere il Concilio, volle richiamare i popoli alla pace, non a caso, nella festa di S. Francesco d’Assisi, il 4 ottobre del 1965, dinanzi ai rappresentanti di 116 nazioni, nel Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York. L’importanza di questo discorso viene dal fatto che nessun Pontefice nella storia aveva mai pronunciato un discorso di pace di persona dinanzi ai rappresentanti diplomatici del più alto consesso mondiale. Il Papa, con grande parresìa e spirito profetico, alla fine del discorso, richiamò le nazioni a fondare la pace sulla fede e sulla conversione a Dio: «Questo edificio, che state costruendo, si regge non già solo su basi materiali e terrene: sarebbe un edificio costruito sulla sabbia; ma esso si regge, innanzitutto, sopra le nostre coscienze. È venuto il momento della “metanoia”, della trasformazione personale, del rinnovamento interiore (…).Il pericolo vero sta nell’uomo, padrone di sempre più potenti strumenti, atti alla rovina ed alle più alte conquiste! In una parola, l’edificio della moderna civiltà deve reggersi su principii spirituali, capaci non solo di sostenerlo, ma altresì di illuminarlo e di animarlo. E perché tali siano questi indispensabili principii di superiore sapienza, essi non possono non fondarsi sulla fede in Dio».
Questo implica due cose, che vanno sempre di pari passo: essere consci della propria debolezza e, con essa, vedere il volto di Dio. C’è un passaggio nel libro della Genesi, che mi piace sempre ricordare, e che indica chiaramente come si riconosce il volto di Dio. Mi riferisco al noto episodio di Giacobbe nella lotta con un misterioso personaggio sulle rive dello Iabbok, nel suo viaggio incontro al fratello Esaù, con il quale si sta arrivando alla resa dei conti. In quella lotta singolare, Giacobbe riconosce il volto di Dio, tanto da chiamare il luogo di quella lotta “Penuèl”, il “volto di Dio”. Da tale travagliata notte esce zoppo, ma confessando: «Ho visto Dio faccia a faccia!» (Gen 32,31). Egli esce sconfitto ma vittorioso, zoppicante ma appoggiato in Dio. Solo zoppicando Giacobbe può andare incontro al fratello-nemico: Esaù lo abbraccia e i due piangono. A questo punto, Giacobbe rivolge a Esaù una delle frasi più belle della Bibbia, talvolta non adeguatamente tradotta e che perciò rendo letteralmente: «Ho visto il tuo volto come si vede il volto di Dio» (Gen 33,10). Solo quando abbiamo sperimentato la nostra debolezza e, in questa, abbiamo incontrato il volto di Dio, siamo pronti ad andare incontro al fratello-nemico. Se non si va incontro all’altro zoppicando, si rischia di aprire costanti scenari di guerra, perché l’altro non è più un altro me stesso, ma un nemico, da temere o da eliminare.
Nella Bibbia vi è comunque anche la prospettiva opposta, di scontro. Il libro del profeta Abdia descrive infatti il lato oscuro di tale relazione, dichiarando a Edom, ai discendenti di Esaù: «A causa della violenza contro Giacobbe, tuo fratello, la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre» (Abd 10). Di qui l’esortazione dello stesso profeta, oggi quanto mai attuale: «Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura» (Abd 12).
- Guardare il volto dell’altro
Quanto da noi appena affermato ci conduce alla seconda caratteristica della pace: oltre a essere una realtà divina, essa è una realtà umana e sociale, un valore universale e un dovere inderogabile che chiama tutti all’appello, pena l’autodistruzione dell’uomo stesso. La pace, tuttavia, anche a livello antropologico, non è solo convenzione sociale, armistizio, mera tregua o assenza di guerra, frutto degli sforzi diplomatici e degli equilibri geopolitici globali o locali, che in Terra Santa stanno purtroppo saltando! Certo, nelle attuali condizioni, tutto questo sarebbe già molto! Eppure, la pace è molto di più: essa si fonda sulla verità della persona umana, che sola può portare a un’autentica omnium rerum tranquillitas ordini (cf. S. Agostino, De Civitate Dei XIX,13,1), perché stabilita secondo giustizia e carità.
Ed ecco, quindi il secondo criterio: rimettere l’uomo al centro, tornare al volto dell’altro, alla centralità della persona umana e della sua ineguagliabile dignità. Quando il volto dell’altro si dissolve, svanisce anche il volto di Dio e quindi la vera pace. Solo nel contesto di uno sviluppo integrale dell’uomo, nel rispetto dei suoi diritti, può nascere una vera cultura della pace e il sorgere di «profeti non armati, purtroppo oggetto di scherno in ogni epoca» (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 496), di testimoni e colonne della pace. Di essi, il mondo ha quanto mai bisogno, anche a costo di essere perseguitati e tacciati come utopici e visionari. Per la pace si deve rischiare, sempre. Si deve essere disposti a perdere l’onore, a morire come Gesù.
Il filosofo ebreo Emmanuel Lévinas affermò: «Nel semplice incontro di un uomo con l’Altro si gioca l’essenziale, l’assoluto. Nella manifestazione, nell’“epifania” del volto dell’Altro scopro che il mondo è mio nella misura in cui posso condividerlo con l’Altro. E l’assoluto si gioca nella prossimità, alla portata del mio sguardo, alla portata di un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto» (L’epifania del volto, cit. in C. Pintus, «Includere per comunicare», in E. Cauda – L. Scursatone [ed.], Educazione, comunicazione e lingua dei segni italiana, Varazze 2017, 14). Nessuno è un’isola: quando si distrugge il volto dell’altro, si dissolve anche il nostro, specialmente nell’era di interconnessione globale in cui viviamo. Se affondiamo, affonderemo insieme, nella stessa barca, perché siamo più che mai in un villaggio globale.
- La missione della Chiesa
Dopo questo sommario sguardo sull’aspetto teologico e umano della pace, bisogna ora venire più direttamente al tema che mi avete proposto e chiedersi come questa dimensione si esprima nella vita della Chiesa. Come la Chiesa sia chiamata a dare tale annuncio e testimonianza. Come ho già detto inizialmente, mi limito qui solo ad abbozzare un pensiero riguardo alla Chiesa di Gerusalemme, basandomi sulla mia esperienza personale, senza alcuna presunzione.
Da molto tempo la nostra Chiesa sta riflettendo su questo nostro contesto di guerra così lacerato; una riflessione che sia costruttiva e allo stesso tempo vera, reale, che non cada in slogan scontati o banalità ovvie. Il conflitto con le sue conseguenze coinvolge la vita di tutti nella nostra diocesi, ed è quindi parte integrante della vita della chiesa, della sua pastorale. Tutto ciò che siamo e che facciamo ha a che fare direttamente e indirettamente con il conflitto e le sue conseguenze, dagli aspetti più pratici fino alla riflessione, sempre più accesa, su temi più complessi: dai confini chiusi e permessi di attraversamento dati e non dati, fino alla riflessione sulla occupazione e sulla possibile risposta cristiana a tale situazione. Ciò che intendo dire è che il conflitto non è una questione temporanea e secondaria della vita della nostra chiesa, ma è parte ormai integrante e costitutiva della nostra identità di Chiesa: conflitto e divisione, con le conseguenze di odio e rancore, sono una realtà ordinaria con la quale dobbiamo fare i conti e che richiede da parte della comunità cristiana un continuo cammino di riflessione e di elaborazione spirituale, pastorale e sociale. Parlare di pace, quindi, per noi non è parlare di un tema astratto, ma di una ferita profonda nella vita della comunità cristiana, che causa sofferenza e stanchezza, e tocca nel profondo la vita umana e spirituale di tutti noi.
Non so se siamo riusciti ad arrivare ad una sintesi nell’interpretazione di questo tema, probabilmente non ancora. Penso che per noi la riflessione riguardo alla testimonianza sulla pace sarà sempre un work in progress, non avremo mai un discorso completo e conclusivo, ma dovremo fare i conti con i continui sviluppi dei vari quadri politici che via via si formano e si disfano, e sulle loro conseguenze sulla vita dei popoli della Terra Santa. Situazioni che interrogano la nostra fede ogni volta daccapo. E forse non è nemmeno questo il tempo della sintesi, ma dell’ascolto. Ascoltare le diverse voci, sentimenti, visioni, fatiche e speranze, e cercare di leggerle alla luce del vangelo, sforzandosi comunque di individuare alcuni tratti comuni, alcune caratteristiche e criteri che dovranno comunque accompagnare stabilmente la nostra riflessione.
Non possiamo, infatti, non chiederci come si fa a vivere la pace a Gerusalemme, città chiamata ad essere la custode della pace, ma continuamente lacerata e contesa.
Per noi Chiesa di Terra Santa, calata in un contesto di società plurireligiosa e pluriculturale, ricca di tante diversità ma anche di divisioni, è chiaro che la «pace di Gerusalemme», di cui parla il salmo 121, non è soppressione delle differenze, annullamento delle distanze ma nemmeno tregua o patto di non belligeranza garantito da patti e da muri. Siamo convinti che essa si basa sull’accoglienza cordiale e sincera dell'altro, sulla volontà tenace di ascolto e di dialogo, che la nostra comunità sia chiamata ad essere strada aperta su cui la paura e il sospetto cedano il passo alla conoscenza, all'incontro e alla fiducia, dove le differenze siano opportunità di compagnia e collaborazione e non pretesto per la guerra.
Dovremo sempre più uscire dalla preoccupazione di occupare strutture fisiche e istituzionali, per concentrarci maggiormente su dinamiche belle e buone di vita che, come credenti, possiamo avviare. Certo: talvolta anche per noi le tentazioni della fuga e della rassegnazione, il facile compromesso con il potere o la risposta violenta possono apparire come l’unica reazione possibile al tempo difficile che ci è dato da vivere.
Come credenti e religiosi, tuttavia, saremo una presenza «interessante» nella misura in cui la nostra profezia sarà la nostra testimonianza quotidiana, perché in un contesto sociale e politico dove la sopraffazione, la chiusura e la violenza sembrano l’unica parola possibile, noi continueremo ad affermare la via dell’incontro e del rispetto reciproco come l’unica via d’uscita capace di condurre alla pace.
La pace ha bisogno della testimonianza di gesti chiari e forti da parte di tutti i credenti, ma ha anche bisogno di essere annunciata e difesa da parole altrettante chiare.
Per questo, ci troviamo spesso a un bivio, quasi chiamati a scegliere tra la necessaria denuncia della violenza e del sopruso, sempre perpetrato a danno dei più deboli, e il rischio di ridurre la religione ad «agente politico» o addirittura a partito o fazione, dimenticandone la vera natura ed esponendola a facili e superficiali strumentalizzazioni. Il nostro stare in Terra Santa come credenti non può rinchiudersi in intimismo devozionale, né può limitarsi solamente al servizio della carità per i più poveri, ma è anche parresìa, non può cioè esimersi dall’esprimere, nei modi propri di ciascuna esperienza religiosa, un giudizio sul mondo e sulle sue dinamiche (cf Gv 16, 8.11). Sappiamo bene come in Medio Oriente la politica avvolga la vita ordinaria in tutti i suoi aspetti. Tutto diventa politica e ciò interroga seriamente tutte le nostre istituzioni religiose e i nostri fedeli, i quali attendono da noi una parola di speranza, di consolazione, ma anche di verità. Si impone qui un discernimento davvero difficile e mai raggiunto una volta per tutte, che richiede la capacità di ascolto di tutte le voci, ma anche di interpretare criticamente, e quindi anche profeticamente, il presente.
Non si può tacere di fronte alle ingiustizie o invitare al quieto vivere e al disimpegno. L’opzione preferenziale per i poveri e i deboli, però, non fa di noi un partito politico. Prendere posizione, come spesso ci è chiesto, non può significare diventare parte di uno scontro, ma deve sempre tradursi in parole e azioni a favore di quanti soffrono e gemono e non in invettive e condanne contro qualcuno. Può essere facile e comodo, a volte, unirsi al coro delle critiche e delle recriminazioni e ci otterrebbe forse anche l’applauso e il consenso, ma potrebbe trattarsi di una tentazione mondana. Siamo chiamati anche noi credenti, insomma, ad amare e servire la polis e condividere con tutti la preoccupazione e l’azione per il bene comune, nell’interesse generale di tutti e specialmente dei poveri, alzando sempre la voce per difendere i diritti di Dio e dell’uomo, ma senza entrare in logiche di competizione e di divisione.
Fatte queste premesse, viene ora da chiedersi: ma come si fa a vivere così, quali sono i caratteri e i criteri, gli elementi sui quali basare questo nostro stile, questo nostro modo di stare in Terra Santa, come cristiani e come chiesa? Quali sono gli elementi che dovranno stabilmente accompagnare la nostra riflessione cristiana sulla pace, i criteri che devono sostenere la nostra interpretazione della situazione presente. Quali sono gli ambiti di azione sui quali fondare una pastorale ecclesiale per la pace solida e credibile? Sono tanti, ovviamente, e sempre in evoluzione, come ho detto precedentemente. Ciò che noi chiamiamo pastorale della pace, non è diversa da qualsiasi altra attività pastorale: ha bisogno di persone, ha bisogno di individuare una metodologia e avere chiaro quali sono i fondamenti spirituali sui quali basare la propria zione, su cosa e per cosa operare.
3.1 Leadership
Nel contesto che abbiamo sopra abbozzato, la responsabilità della leadership religiosa, specialmente in Medio Oriente, è essenziale. Per prima cosa è necessario avere guide, pastori, leader capaci non solo di ascoltare e di essere voce della propria comunità, ma anche di orientare e di guidare.
Invece di essere il supporto religioso di regimi politici poco credibili, la leadership religiosa dovrebbe prima di tutto cooperare con tutta la parte migliore della società nel creare una nuova cultura della legalità, e diventare una voce libera e profetica di giustizia, diritti umani e pace. Come abbiamo affermato inizialmente, questi valori non sono solo valori umani, ma prima di tutto sono espressione del desiderio di Dio per l’uomo. Il nostro contributo come leadership religiosa alla resilienza e all’innovazione in mezzo alle attuali enormi sfide locali non è quello di inventare di nuovo la ruota: trovare, cioè, nuove e moderne strategie operative, ma di essere noi stessi testimoni credibili, sinceri e appassionati di Dio.
Mi chiedo se nelle azioni e nelle parole che uso, temo più Dio oppure la reazione della gente, dei politici, dei media… Nel mio rivolgermi alla mia comunità, ho il coraggio della parresia, dell’orientamento? Apro orizzonti? O mi limito a pesare le parole per non essere di disturbo a nessuno?
Non è un tema banale. Direi anzi che sia centrale. Soprattutto in questi contesti di dolore e disorientamento, in un contesto dove la religione ha un ruolo pubblico così rilevante, non si deve mai smettere di chiedersi se e come la fede possa orientare la propria comunità, ad invitarla ad interrogarsi, senza adagiarsi. La fede deve essere conforto, sostegno, ma anche in un certo senso elemento di disturbo. Se la fede si basa su un’esperienza di trascendenza, essa deve anche portare il pensiero a trascendere il momento presente, e aprire i confini di mente e cuore, ad andare oltre.
In Dt 30, 15, Dio dice: “Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male… Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza”. Dobbiamo prendere atto che si può dunque non scegliere la vita e il bene, e lo vediamo ogni giorno. Dobbiamo tuttavia anche chiederci come porci di fronte a chi compie quelle scelte di male e morte, quale sia l’atteggiamento giusto di un credente verso quelle responsabilità. Come i leader religiosi devono agire e comportarsi in quelle specifiche situazioni, che orientamento dare alle proprie comunità riguardo non ad un male generico, ma chi quel male lo compie, come leggere quelle situazioni, oggettivamente sbagliate, alla luce della Parola di Dio?
Fede e politica, piaccia o no, hanno sempre avuto una stretta relazione tra loro sul piano delle relazioni sociali. In Medio Oriente la fede, le religioni hanno una funzione per la vita delle comunità nazionali e la politica ha sempre dovuto di conseguenza avere a che fare la religione e la sua funzione pubblica.
Ogni generazione, inoltre, ha sempre dovuto individuare i criteri e le forme per regolare il rapporto tra questi due ambiti della vita sociale di ogni Paese. La nostra generazione e quelle future, si trova di fronte a sfide che possiamo definire uniche nel loro genere, poiché in questi tempi non si tratta solo di definire i rapporti tra le due sfere su menzionate, ma anche di ripensare la politica e la religione e il loro ruolo in sé, al loro interno e non solo in rapporto all’altro. Non di rado politica nazionale e religione si trovano oggi sul banco degli imputati, accusate del male odierno, o di incapacità, di arretratezza, e così via.
La fede religiosa, inoltre, ha un ruolo fondamentale nel ripensamento delle categorie della storia, della memoria, della colpa, della giustizia, del perdono, che pongono in contatto direttamente la sfera religiosa con quella morale, sociale e politica. Non si supereranno i conflitti interculturali se non si rileggono e si redimono le letture diverse e antitetiche delle proprie storie religiose, culturali e identitarie. Le ferite causate nel passato remoto e recente, come pure quelle attuali, se non sono curate, assunte, elaborate, condivise, continueranno a produrre dolore anche dopo anni o addirittura secoli. A questo proposito così ha affermato Papa Francesco:
In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia. Nuovo incontro non significa tornare a un momento precedente ai conflitti. Col tempo tutti siamo cambiati. Il dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato. Inoltre, non c’è più spazio per diplomazie vuote, per dissimulazioni, discorsi doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà. Quanti si sono confrontati duramente si parlano a partire dalla verità, chiara e nuda. Hanno bisogno di imparare ad esercitare una memoria penitenziale, capace di assumere il passato per liberare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, confusioni e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo sforzo perseverante e duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il bene di tutti. La realtà è che «il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza comune, più forte della vendetta»1.
Questi percorsi non si fanno da soli. Le comunità nazionali, politiche o religiose che siano, hanno bisogno di chi sappia promuovere, orientare, guidare verso quella comprensione di sé e dell’altro, a volte anche a costo di pagare un prezzo alto in termini di solitudine, incomprensioni e rifiuto.
Naturalmente la pace non è responsabilità esclusiva del pastore e/o del leader religioso. Non vorrei dare l’impressione che la pace la fanno solo i leaders. Essi però sono chiamati a guidare, accompagnare, oltre che ad ascoltare, le loro rispettive comunità, a creare i contesti nei quali le comunità si possano esprimere. Il pastore da solo non fa la comunità, ma la comunità non può sussistere senza un pastore. Nel dialogo continuo, nell’ascolto reciproco, nella condivisione nasce e si sviluppa una seria pastorale di pace. Resta dunque imprescindibile il ruolo di guida, di profeta e di voce del pastore.
3.2 Dialogo interreligioso
Come disse saggiamente il rabbino J.A. Heschel, nessuna religione è un’isola. La Chiesa, quindi, non può presumere di operar una pastorale per la pace da sola, come fosse l’unica realtà del territorio. Vi sarebbe in ciò molta presunzione. Come se tutto il mondo fosse in attesa della nostra parola e testimonianza. Non è così. Almeno non è così in Terra Santa. Come ormai un tutto il mondo, viviamo in un contesto pluriculturale e plurireligioso. Senza la collaborazione delle altre Chiese e delle altre comunità religiose, nessuna pastorale ecclesiale della pace potrà avere consistenza. Il collaborare con altri da sé sulla pace aiuterà anche a guarire i problemi interni alle nostre comunità, perché è solo in una sincera relazione con l’altro che possiamo definirci al meglio e in verità.
Le diverse fedi, se intese nella loro genuinità e nella loro vocazione profonda, sono portatrici di risorse di riconciliazione e di pacificazione e non rappresentano quasi mai la sola o la principale causa scatenante delle incomprensioni e dei conflitti, né costituiscono di per sé un fattore di rischio in questo senso. Ma se diventano funzionali alla lotta politica, come spesso accade in Terra Santa, le religioni diventano come benzina gettata sul fuoco.
Il dialogo interreligioso ha prodotto documenti molto belli sulla fraternità umana, sull’essere tutti figli di Dio, sulla necessità di lavorare insieme per il rispetto dei diritti della persona… Sono tutti frutti di un’attività che considero spirituale.
Eppure, in questo nostro attuale contesto di guerra, tutto questo in Terra Santa sembra oggi essere lettera morta
Vi è un grande assente in questa guerra: la parola dei leader religiosi. Con poche eccezioni, non si sono sentite in questi mesi da parte della leadership religiosa discorsi, riflessioni, preghiere diverse da qualsiasi altro leader politico o sociale. Spero di essere smentito, ma si ha l’impressione che ciascuno si esprima esclusivamente all’interno della prospettiva della propria comunità.
Rapporti di carattere interreligioso che sembravano consolidati sembrano oggi spazzati via da un pericoloso sentimento di sfiducia. Ciascuno si sente tradito dall’altro, non compreso, non difeso, non sostenuto.
Mi sono chiesto più volte, in questi mesi, se la fede in Dio sia davvero all’origine del pensiero e della formazione della coscienza personale, creando così tra noi credenti una comprensione comune almeno su alcune questioni centrali della vita sociale, oppure se il nostro pensiero si formi e si basi su altro.
Questa guerra è uno spartiacque nel dialogo interreligioso, che non potrà essere più come prima, almeno tra cristiani, musulmani ed ebrei.
Il mondo ebraico non si è sentito sostenuto da parte dei cristiani e lo ha espresso in maniera chiara. I Cristiani a loro volta, divisi come sempre su tutto, incapaci di una parola comune, si sono distinti se non divisi sul sostegno ad una parte o all’altra, oppure incerti e disorientati. I musulmani si sentono attaccati, e ritenuti conniventi con gli eccidi commessi il 7 ottobre… insomma dopo anni di dialogo interreligioso, ci siamo ritrovati a non intenderci l’un l’altro. È per me, personalmente, un grande dolore, ma anche una grande lezione.
Partendo da questa esperienza, dovremo ripartire, coscienti che le religioni hanno un ruolo centrale anche nell’orientare, e che il dialogo tra noi dovrà forse fare un passaggio importante, e partire dalle attuali incomprensioni, dalle nostre differenze, dalle nostre ferite. Non potrà essere più un dialogo solo tra appartenenti alla cultura occidentale, c come è stato fino ad oggi, ma dovrà tenere in conto le varie sensibilità, i vari approcci culturali non solo europei, ma innanzitutto locali. È molto più difficile, ma da lì si dovrà ripartire.
E si dovrà farlo, non per bisogno o necessità, ma per amore. Perché, nonostante le nostre differenze, ci vogliamo bene, e vogliamo che questo bene trovi espressione concreta nella vita non solo personale, ma anche delle nostre rispettive comunità. Volersi bene, non significa necessariamente avere le stesse opinioni, ma saperle esprimere ed apprezzare, rispettandosi ed accogliendosi l’un l’altro.
Quando è sincero e affronta le questioni relative al proprio territorio e alle rispettive comunità, il dialogo interreligioso crea mentalità di incontro e di rispetto reciproco, crea quel necessario background sul quale poi fondare anche le successive prospettive politiche.
3.3 Il perdono.
Dopo avere individuato le responsabilità imprescindibili della leadership religiosa riguardo ad una seria pastorale per la pace, e la modalità ‘aperta’ con la quale operare, bisogna ora chiedersi su cosa i leader religiosi devono attivarsi, sia all’interno delle loro rispettive comunità, sia in dialogo tra loro. Per cosa si deve operare, come e con quale stile le proprie comunità devono vivere questa dimensione centrale della propria fede?
Direi che il tema centrale è il perdono. Non si può parlare di pace in maniera astratta, come fosse un’idea. La pace non è qualcosa che si deve fare, ma è un modo di stare nella vita, un atteggiamento integrale della persona e della comunità, che in ogni contesto – personale e collettivo - deve fare i conti con le ferite causate dalle divisioni, dagli atteggiamenti di possesso ed esclusione, odio. In una parola deve fare i conti con il peccato. E in questo contesto la pace è strettamente legata al perdono. Direi che possano essere considerati se non sinonimi, comunque strettamente necessari l’uno all’altra.
La rivelazione biblica ci dice che come la pace, così anche il perdono ha la sua radice nell’amore di Dio, e richiede innanzitutto un cammino personale, un percorso di comprensione, di “assunzione” del male ricevuto o commesso. Esso non può mai arrivare per inerzia. Il male commesso non si dimentica, ma richiede una precisa volontà di superamento, che è frutto di un desiderio chiaro e definito. Non cancella il torto subito, ma lo vuole superare per un bene maggiore. Cercare di dimenticare, aspettare che il tempo da solo curi le ferite, non assumere il male commesso, identificandolo, guardandolo in faccia, chiamandolo con il suo nome, significa fare del perdono un gesto banale, che non risana alcuna ferita, non cambia il cuore delle persone e non produce pace.
A livello sociale e politico, la riflessione sul perdono richiede tempi lunghi. I percorsi da compiere sono spesso enormemente complessi, perché devono tenere in considerazione non una relazione personale o di un contesto specifico, ma quella sociale. Si devono cioè prendere in considerazione le ferite collettive, il dolore di tutti, le necessariamente diverse comprensioni degli eventi all’origine del dolore comune, i tempi diversi di comprensione.
Per guardare al futuro con speranza e in pace, è necessario fare un percorso di purificazione della memoria. Le ferite, se non sono curate, creano un atteggiamento di vittimismo e di rabbia, che rendono difficile, se non impossibile, la riconciliazione. Finché da parte di tutti non vi sarà una purificazione della comune memoria, fino a che non ci sarà un reciproco riconoscimento del male reciprocamente commesso e subìto, fino a che, insomma, non vi sarà una rilettura delle proprie relazioni storiche, le ferite del passato continueranno ad essere un bagaglio da portare sulle proprie spalle e un criterio di lettura delle relazioni reciproche.
La fede ha naturalmente la capacità di aprire il credente alla relazione, perché lo apre all’incontro con Dio, che diventa poi naturalmente anche sguardo all’altro da sé.
Ma è anche necessaria un’educazione umana al perdono, una formazione culturale che consenta all’uomo di guardare gli eventi non esclusivamente dalla prospettiva delle proprie ferite, che hanno sempre un orizzonte limitato e chiuso, e lo aiuti ad interpretare gli eventi, personali e collettivi, con uno sguardo verso il futuro, che tenga in considerazione anche il bene della realtà umana e sociale circostante, il bisogno di riattivare dinamiche di vita. In questo contesto, dunque, la riflessione sul perdono può aprirsi anche ai non credenti.
Il primo frutto del perdono è la libertà dai lacci emotivi prodotti dal rancore e dalla vendetta, che imprigionano ogni prospettiva di relazione dentro un cerchio di dolore e di violenza. Il perdono permette la guarigione dell’animo umano, riattiva le dinamiche di vita e apre al futuro.
Occorre agire capillarmente in tutti gli ambiti: politico, religioso e civile, contemporaneamente, compresi i diversi gruppi di aggregazione e formazione del pensiero come scuola, università e mass media, perché la persona interagisce a tutti questi livelli insieme, e il perdono, nella sua funzione di guarigione del soggetto, può agire solo se coinvolge tutte le fibre del suo essere.
La Chiesa, insieme alle altre comunità di fede, ha un ruolo fondamentale nella educazione alla riconciliazione, nel creare il contesto per un approccio al perdono, ma non lo può imporre. È necessario dare tempo e rispettare il dolore di chi soffre, aiutandolo però anche a rileggere la propria storia, permettendo che le ferite guariscano. Spesso in Terra Santa si tratta di sapere attendere. Non sempre il cuore delle persone e delle comunità è pronto e libero per parlare di perdono. Il dolore è ancora troppo forte. Spesso è più facile avere a che fare con rabbia più che con desiderio di perdono. Bisogna, perciò, sapere attendere, ma allo stesso tempo proporre senza stancarsi la via cristiana della pace.
Tutti gli accordi di pace in Terra Santa, finora, sono di fatto falliti, perché erano spesso accordi teorici, che presumevano di risolvere anni di tragedie senza tenere in considerazione l’enorme carico di ferite, dolore, rancore, rabbia che ancora covava e che in questi mesi è esploso in maniera estremamente violenta. Non si è tenuto conto, inoltre, del contesto culturale e soprattutto religioso, che invece parlava una lingua esattamente contraria (a cominciare dai leader religiosi locali) da quella di chi parlava di pace.
In questo contesto, dunque, la pastorale della chiesa non può non avere nel suo orizzonte di azione la proposta di perdono e riconciliazione, che tenga conto delle ferite e del dolore, ma che non si ferma ad esso. Il dolore può chiudere in se stessi, ma può anche aprire a nuove dimensioni, può trasformarsi in risurrezione. Senza questa prospettiva, in Terra Santa nessun progetto politico potrà avere successo, e la pace resterebbe solo uno slogan poco credibile. Compito della pastorale della Chiesa, dunque è quello di proporre senza stancarsi percorsi di riconciliazione, accompagnare gli sforzi di guarigione, proporre linguaggi che non escludano nessuno, tessere pazientemente trame di relazioni, costruire con gesti concreti la fiducia all’interno della propria comunità ecclesiale, innanzitutto, e poi con le altre comunità religiose.
3.4 Verità e Giustizia
Il perdono, come dicevo, è un tema centrale per la pastorale della pace. Ma nel nostro contesto, il perdono non può essere disgiunto da due altre parole: verità e giustizia.
La sofferenza, il dolore, le ferite che questo conflitto ha causato sono conosciute. Non sono qui per fare l’elenco dei mali che si compiono. Non è questo il tema di questo incontro, e del resto penso che sia un tema noto a tutti. E non intendo in questa sede entrare nella questione di questa fase del conflitto in corso ora, iniziato il 7 ottobre scorso.
Da decenni in Terra Santa sussiste l’occupazione israeliana dei territori della Cisgiordania, con tutte le sue drammatiche conseguenze sulla vita dei palestinesi e anche degli israeliani. La prima conseguenza e la più visibile di questa situazione politica è la condizione di ingiustizia, di non riconoscimento di diritti basilari, di sofferenza nella quale vive la popolazione palestinese in Cisgiordania. È un’oggettiva situazione di ingiustizia.
Come ho detto poc’anzi, per la nostra Chiesa il conflitto con le sue conseguenze, è parte integrante della vita ordinaria, ed è inevitabilmente parte del pensiero e della riflessione di tutta la comunità. Non di rado, come in questo periodo, si tratta di una riflessione e di una discussione dura e dolorosa. Mantenere la comunione tra i cattolici palestinesi e israeliani, in questo contesto lacerato e polarizzato, è quanto mai arduo.
Non si può, quindi, parlare di perdono, senza allo stesso tempo parlare di verità e giustizia. Non dire una parola di verità sulla vita di un palestinese, la cui vita da decenni è in attesa che gli sia riconosciuta giustizia e dignità, significherebbe giustificare una oggettiva situazione ingiustizia.
Come Patriarca latino di Gerusalemme, mi sono trovato, fin dall’inizio di questo conflitto, in una situazione che richiede una scelta, una presa di posizione chiara e precisa. Come conciliare questa richiesta di schieramento con quello che sono e con quanto ho appena detto riguardo al perdono? Come difendere i diritti di Dio e dell’uomo in questo contesto, come cioè parlare di perdono, essere fedeli a Cristo che sulla croce perdona gratuitamente, senza dare l’impressione di non difendere il gregge a me affidato, i suoi diritti, le sue attese? Come predicare l’amore ai nemici senza dare l’impressione di confermare involontariamente una narrativa contro l’altra, israeliana contro quella palestinese, o viceversa? Come risanare le divisioni con scelte ferme e giuste, ma senza creare altre divisioni e sempre con misericordia?
Più concretamente, mi si chiede spesso: “Come posso pensare di perdonare l’israeliano che mi opprime, finché sono sotto oppressione? Non significherebbe dargliela vinta, lasciargli campo libero senza difendere i miei diritti? Prima di parlare di perdono non è forse necessario che si faccia giustizia?”. L’israeliano, a sua volta, potrà aggiungere: “Come posso perdonare chi uccide la mia gente in maniera così barbara?” Sono domande dietro alle quali vi è un dolore reale, sincero, da rispettare.
Non so se sia possibile rispondere a queste domande, ma non si può evitare di porsele. Una pastorale per la pace non può ignorare le ferite della propria comunità, e non può nemmeno illuderla con facili risposte, che non toccano la vita reale. Ci sono situazioni che non hanno soluzioni immediate e forse non hanno affatto soluzioni. Ma c’è comunque un modo cristiano di stare dentro un conflitto. La pace si può vivere anche in queste circostanze. Spesso più che risposte facili, che probabilmente non esistono, si deve aiutare ad individuare percorsi e stili di vita.
Ho provato ad indicarne alcuni, con una lettera alla diocesi inviata qualche mese fa, che qui mi permetto di riportare:
“Avere il coraggio dell’amore e della pace in Terra Santa, oggi, significa non permettere che odio, vendetta, rabbia e dolore occupino tutto lo spazio del nostro cuore, dei nostri discorsi, del nostro pensare. Significa impegnarsi personalmente per la giustizia, essere capaci di affermare e denunciare la verità dolorosa delle ingiustizie e del male che ci circonda, senza però che questo inquini le nostre relazioni. Significa impegnarsi, essere convinti che valga ancora la pena di fare tutto il possibile per la pace, la giustizia, l’uguaglianza e la riconciliazione. Il nostro parlare non deve essere pieno di morte e porte chiuse. Al contrario, le nostre parole devono essere creative, dare vita, creare prospettive, aprire orizzonti.
Ci vuole coraggio per essere capaci di chiedere giustizia senza spargere odio. Ci vuole coraggio per domandare misericordia, rifiutare l’oppressione, promuovere uguaglianza senza pretendere l’uniformità, mantenendosi liberi. Ci vuole coraggio oggi, anche nella nostra diocesi e nelle nostre comunità, per mantenere l’unità, sentirsi uniti l’uno all’altro, pur nelle diversità delle nostre opinioni, delle nostre sensibilità e visioni.
Io voglio, noi vogliamo essere parte di questo nuovo ordine inaugurato da Cristo. Vogliamo chiedere a Dio quel coraggio. Vogliamo essere vittoriosi sul mondo, assumendo su di noi quella stessa Croce, che è anche nostra, fatta di dolore e di amore, di verità e di paura, di ingiustizia e di dono, di grido e di perdono” (lettera alla diocesi, 24.10.2023).
Il perdono, in conclusione, da solo non può costruire la pace. Verità e giustizia, da sole non possono costruire la pace. La relazione tra queste parole non è mai facile ed è fonte di grandi discussioni, ma anche di belle riflessioni.
Parlare solo di perdono, disgiunto da verità e giustizia, in questo nostro preciso contesto, significa non tenere conto che l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, significa ignorare la sua dignità di persona, con tutti i diritti legati a tale sua identità. Parlare di perdono, senza tenere conto del diritto della persona ad una vita giusta e dignitosa, è negare un diritto di Dio, e non costruisce la pace.
Verità e giustizia, disgiunte dal perdono, hanno la stessa limitazione. Affermare il bisogno di verità e di giustizia è attività sacrosanta, ma se queste sono disgiunte da un desiderio di perdono, cioè di superamento del male commesso, mettono il proprio avversario con le spalle al muro, senza vie di uscita. Lo lasciano sul banco degli imputati, mettendolo di fronte alle proprie responsabilità, ma senza superarle, senza offrire prospettive di uscita. In definitiva diventa recriminazione e basta. Tutto ciò può anzi provocare una reazione ancora più aggressiva di opposizione.
È necessario, dunque, che la pastorale ecclesiale sappia porre questi tre elementi in continuo, difficile, doloroso, complesso, lacerante, faticoso dialogo tra loro. Ma è un processo fruttifero e rispettoso dei diritti di Dio e dell’uomo, e costruttore, poco alla volta, nei tempi che non possediamo, prospettive di pace. Perché ciò che sostiene questi tre modi di stare nella vita e le relazioni tra noi non è una ideologia, ma è l’amore. “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5 ). È quell’amore l’anima del nostro desiderio di pace. Niente altro.
Conclusione
In conclusione, posso dire che a mio avviso la pastorale della pace nella Chiesa non consiste in null’altro che essere semplicemente chiesa. Rimanere se stessi, ancorati a ciò che ci sostiene, e viverlo, annunciarlo e testimoniarlo senza paura e ipocrisia.
A questo proposito, permettetemi di aggiungere una piccola riflessione. In Terra Santa assistiamo dolorosamente alla crisi crescente degli organismi multilaterali, come ad esempio l’ONU, sempre più impotente e, per molti, ostaggio delle grandi potenze (basti pensare i vari poteri di veto). La comunità internazionale è sempre più debole, e così i vari altri organismi internazionali.
In breve, quanti a livello internazionale sono deputati al mantenimento e alla promozione della pace, alla difesa dei diritti, alla costruzione di modelli di società dignitosi, hanno mostrato tutta la loro debolezza. La leadership locale è ancora più in difficoltà, di ogni genere. Realtà purtroppo a tutti assai nota.
Mancano, insomma, riferimenti politici e sociali capaci di porre gesti nel territorio che costruiscano fiducia, capaci di scelte coraggiose di pace, di negoziare riconciliazioni, di accettare i necessari compromessi, e così via.
In questo contesto così desolante, gli operatori pastorali, i pastori, la Chiesa, devono fare attenzione a non cadere in una facile tentazione: quella di sostituirsi a quegli organismi, e di entrare in dinamiche di negoziazioni politiche che per loro stessa natura sono soggette a mai facili compromessi, spesso anzi dolorosi e controversi. La tentazione di colmare il vuoto lasciato dalla politica è facile, e anche la richiesta da parte di molti di colmare quel vuoto è sempre insistente.
Ma non è questo il compito della Chiesa, che - come dicevo - deve rimanere chiesa, comunità di fede, che non significa essere avulsi dalla realtà, ma anzi essere sempre disposti ad impegnarsi con chiunque per costruire la pace, per facilitare la creazione di contesti che aiutino a costruire prospettive politiche, ma rimanendo se stessa, senza entrare in dinamiche politiche che non le appartengono, e che per loro natura sono spesso estranee alle logiche del Vangelo.
La pastorale della pace ha solo il Vangelo come riferimento. I caratteri e i criteri per costruire la pace si trovano tutti li. Da li si deve partire e li si deve tornare sempre. E il contributo che possiamo portare alla vita sociale della nostra travagliata diocesi consiste nel creare nella comunità il desiderio, la disposizione e l’impegno sincero, leale, positivo e concreto di incontro con l’altro, nel saperlo amare nonostante tutto, nell’aiutare ad interpretare il proprio dolore alla luce della fede, a sapere fare unità tra fede e vita. Partendo dall’ascolto della Parola di Dio, che è la fonte principale di ogni criterio di interpretazione della nostra realtà di vita.