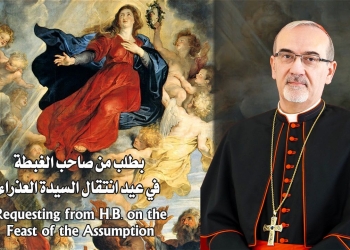Gerusalemme. Tra Realtà e Vocazione: Una Luce per la Pace
Friburgo, 14 novembre 2025
Autorità Accademiche,
Illustri Colleghi,
Care Studentesse e Cari Studenti,
Signore e Signori.
È per me un onore profondo, e una responsabilità ancor più grande, trovarmi in questa sede oggi. Sono qui non come esperto di questioni internazionali e geopolitiche, né come accademico specializzato in relazioni internazionali, ma come pastore, come testimone che proviene dall’esperienza viva della Terra Santa. Sono presente per tentare di tradurre il grido silenzioso di una terra che, ancora oggi, sanguina e spera. E da pastore, conseguentemente, desidero esprimermi.
Non intendo in questa sede enumerare la cronaca di questi due anni, che ciascuno ha avuto modo di seguire attraverso i media. Ora che la fase acuta del conflitto sembra conclusa, anche se tutto resta ancora da ricostruire, nelle infrastrutture ma più ancora nel senso di umanità e di fiducia, abbiamo però forse più di prima lo spazio interiore per cercare di comprendere cosa e come questo scontro armato abbia modificato in maniera determinante non solo le nostre percezioni personali, ma anche i rapporti tra le varie comunità.
Se dovessi racchiudere in un’immagine la condizione dell’uomo in Terra Santa in questi mesi, userei questa: il dolore che non vede il dolore. Il cuore è così pieno, così invaso, così lacerato dal proprio patire, da non riuscire a trovare nemmeno un millimetro di spazio per la sofferenza dell’altro. Ciascuno si sente vittima, l’unica vittima, di questo tsunami di ostilità.
E in questo panorama di macerie materiali e morali, la recente tregua ci ha portato un sollievo precario, sì, ma non la serenità. La fine delle ostilità non coincide con l’inizio della riconciliazione. Le ferite sono troppo profonde.
Allora, da dove ricominciare? Quale linguaggio utilizzare quando tutte le parole sembrano consumate? Quale orizzonte indicare quando il fumo delle esplosioni ha offuscato così a lungo il nostro cielo?
È da questo interrogativo che nasce la mia riflessione di oggi. Vorrei condurvi in un percorso che dalla realtà cruda di una terra ferita, si elevi verso una vocazione eterna. Un percorso il cui faro, la cui bussola, è il simbolo più potente e contraddittorio che la storia umana conosca: la città di Gerusalemme.
Non approfondirò questioni e responsabilità politiche. Non perché abbia timore di farlo. Ho già ribadito più volte la mia opinione al riguardo, e non è necessario che mi ripeta. Oltretutto questa prestigiosa sede mi obbliga a riflessioni che cercherò di mantenere elevate. Proverò a scalfire la superficie del reale, per interrogare un’idea, un sogno, una vocazione iscritta nel cuore stesso della Rivelazione.
1.0 La Realtà — Le Macerie del Presente
Per prima cosa, come dicevo, è necessario che si prenda coscienza di dove ora ci troviamo, nelle relazioni comunitarie, nelle prospettive sociali e politiche, nella vita religiosa, che un’influenza così importante ha nella vita civile dei popoli della Terra Santa. Dal 7 ottobre 2023, siamo stati immersi in un mare di sangue e fuoco. Abbiamo vissuto la morte, la distruzione, il rancore, il desiderio di vendetta. E, con l’aiuto di Dio, abbiamo tentato di essere ponte, di tenere viva una scintilla di speranza. Ora, il cessate il fuoco ha portato scene di giubilo. Ma la gioia è accompagnata da uno scetticismo profondo. Perché sappiamo che la vera sfida inizia adesso.
- La crisi ha danneggiato anni di faticoso dialogo interreligioso, che ora cerca laboriosamente di ripartire.
- Ha smantellato l’illusione di facili prospettive di pace, di una soluzione a breve della questione politica israelo-palestinese.
- Ha diviso le comunità al loro interno, lasciando ognuno chiuso nel proprio dolore, nella propria rabbia, nella propria delusione, e minando la fiducia della popolazione nelle rispettive leadership politiche.
Per prima cosa, mi soffermerò brevemente su questi tre punti, pur sapendo che vi sono anche altre tematiche non meno importanti, come ad esempio il ruolo della comunità internazionale e degli organismi multilaterali, l’attualità ed efficacia delle convenzioni internazionali e molto altro.
Cercherò poi, usando l’immagine della Gerusalemme dell’Apocalisse, di individuare alcune prospettive future, a specificare quale invece debba essere la nostra vocazione.
1.1 Dialogo interreligioso
L’odio profondo, la contrapposizione politica e militare sono un dato evidente. Ma vi è anche una sorta di “conflitto spirituale”, se possiamo chiamarlo così. Non entro ora in disquisizioni teologiche o spirituali, che pure sarebbero interessanti e utili. Non mi riferisco alla lotta tra il bene e il male, come a dire che il bene è da una parte e il male dall’altra, come è anche stato detto più volte da molti in questo conflitto. Ma è chiaro che l’avversione profonda e le sue conseguenze di morte e dolore, e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, quella profonda ostilità costituisce una sfida non indifferente per la vita spirituale della Terra Santa, per chi vede nell’esistenza del mondo e delle persone un riflesso della presenza di Dio. Questo scontro armato intacca in maniera chiara la vita interiore degli abitanti della Terra Santa. Quanto sta accadendo non può lasciare indifferenti quanti hanno a cuore la vita nello spirito. In Terra Santa fede e religione sono decisivi per l’esistenza delle diverse comunità, cristiani, musulmani ed ebrei. In questo conflitto, dunque, che ha avuto un impatto devastante sulla vita di tutti, qual è stato il ruolo delle fedi e delle religioni?
Il progresso sociale ci ha portato ad avere oggi una coscienza sempre più chiara dei valori essenziali del vivere civile. Il mondo si riconosce sempre di più su alcune poche parole, comuni a tutti: giustizia, uguaglianza, pace, dignità di ogni essere umano, persona, solo per citarne alcune. Gli organismi internazionali, dopo le tragedie del ‘900, hanno prodotto documenti importanti sulle relazioni tra i popoli, anche in caso di conflitti, con leggi internazionali molto chiare. Il dialogo interreligioso a sua volta ha prodotto documenti molto belli sulla fraternità umana, sull’essere tutti figli di Dio, sulla necessità di lavorare insieme per il rispetto dei diritti della persona... Sono tutti frutti di un’attività che considero spirituale, soprattutto l’ultima, che per ovvie ragioni mi è più vicina.
Eppure, in questo nostro attuale contesto, tutto questo sembra essere stato lettera morta. Pare, insomma, che le parole dello spirito nel senso citato ora non abbiano avuto alcuna influenza nelle decisioni che si sono prese. Ci è sembrato che si sia mossi solo da un risentimento cieco, l’uno nei confronti dell’altro, e che questo sia stato il criterio principale di riferimento nelle scelte compiute.
Bisogna riconoscere, inoltre, che vi è stato e ancora sussiste un grande assente in questo conflitto: la parola dei leader religiosi. Con poche eccezioni, soprattutto in questo ultimo periodo, non si sono sentite in questi mesi da parte della leadership religiosa dichiarazioni, riflessioni, preghiere diverse da qualsiasi altro leader politico o sociale. Si ha l’impressione che ciascuno si esprima esclusivamente all’interno della prospettiva della propria comunità.
Ebrei con ebrei, musulmani con musulmani, cristiani con cristiani, e così via. Che ciascuno custodisca e consolidi la narrativa della propria comunità di appartenenza, non di rado contro l’altra.
Durante il conflitto è stato ed è ancora piuttosto difficile, ad esempio avere incontri di carattere interreligioso, almeno a livello pubblico. Religiosi ebrei, musulmani e cristiani non riescono ad incontrarsi, nemmeno per esprimere le proprie differenze di vedute. Rapporti di carattere interreligioso che sembravano consolidati, come ho accennato inizialmente, sono oggi come sospesi. Ciascuno si sente tradito dall’altro, non compreso, non difeso, non sostenuto.
Mi sono chiesto più volte, in questi mesi, se la fede in Dio sia davvero all’origine del pensiero e della formazione della coscienza personale, creando così tra noi credenti una comprensione comune almeno su alcune questioni centrali della vita sociale, oppure se il nostro pensiero si formi e si basi su altro. In altre parole, mi chiedo se nelle azioni e nelle parole che uso, temo più Dio oppure la reazione della gente, dei politici, dei media... Nel mio rivolgermi alla mia comunità, ho il coraggio della parresia, dell’orientamento? Apro orizzonti? O mi limito a pesare le parole per non essere di disturbo a nessuno? I profeti di cui parlavo all’inizio, sono solo ricordi del passato?
Non è un tema banale. Soprattutto in questi contesti di dolore e disorientamento, in un contesto dove la religione ha un ruolo pubblico così rilevante, non si deve mai smettere di chiedersi se e come la fede possa orientare la propria comunità, ad invitarla ad interrogarsi, senza adagiarsi. La fede deve essere conforto, sostegno, ma anche in un certo senso elemento di disturbo. Se la fede si basa su un’esperienza di trascendenza, essa deve anche portare il pensiero a trascendere il momento presente, e aprire i confini di mente e cuore, ad andare oltre. I credenti, infatti, possono orientare la loro rabbia e il loro dolore nella preghiera, dovrebbero alzare lo sguardo e vedere che Dio alla fine li chiama a guardare l’altro, creato a immagine e somiglianza di Dio.
Questo conflitto rappresenta anche uno spartiacque nel dialogo interreligioso, che non potrà essere più come prima, almeno tra cristiani, musulmani ed ebrei. Le rispettive comunità religiose non si sono sentite sostenute, quando non addirittura osteggiate dalle altre. Le ondate di antisemitismo nel mondo sono diventate anche oggetto di accusa nei confronti dei cristiani da parte delle comunità ebraiche, che non si sentono sostenute. Le comunità islamiche si considerano oggetto di sentimenti di islamofobia. I cristiani sono accusati un po’ da tutti, oltre ad accusarsi tra loro. Insomma, non sembrerebbe che in un momento di verità come questo si sia stati capaci di intendersi e di dire una parola comune forte ed autorevole, con poche eccezioni.
Nel passato avevo detto, suscitando anche qualche polemica, che il 7 ottobre e la guerra di Gaza hanno spazzato via anni di dialogo interreligioso. Oggi sono meno drastico. Lo vediamo anche nel contesto delle varie celebrazioni dei 60 anni del documento "Nostra Aetate". Questo spartiacque non ha cancellato anni di dialogo interreligioso, ma — a mio avviso — ha concluso una fase del cammino che abbiamo fatto fino ad oggi, una tappa importante. Non potremo più limitarci a valutare quanto è stato e non è stato fatto nel nostro comune passato, ma partire dalle nostre esperienze di vita presenti e discutere tra noi dei temi centrali per le nostre rispettive comunità oggi: la relazione della religione con la politica, le diverse interpretazioni della Scrittura, il concetto di persona, di diritti e di dignità, di identità personale e collettiva... insomma dei temi che coinvolgono direttamente la sfera religiosa con la vita civile e sociale delle nostre rispettive comunità.
Partendo da questa esperienza, dovremo ripartire, coscienti che le religioni hanno un ruolo centrale anche nell’orientare, e che il dialogo tra noi dovrà forse fare un passaggio importante, e partire dalle attuali incomprensioni, dalle nostre differenze, dalle nostre ferite.
E si dovrà farlo, non per bisogno o necessità, ma per amore. Perché, nonostante le nostre differenze, ci vogliamo bene, e vogliamo che questo bene trovi espressione concreta nella vita non solo personale, ma anche delle nostre rispettive comunità. Volersi bene, non significa necessariamente avere le stesse opinioni, ma saperle esprimere ed apprezzare, rispettandosi ed accogliendosi l’un l’altro.
1.2 Il linguaggio della politica
La politica, ovviamente, ha giocato e continuerà a giocare il ruolo principale in questa crisi. Sia quella locale che quella internazionale, come abbiamo visto. Ma, come ho già detto inizialmente, di questo noi non parleremo in questa sede. Vorrei però toccare un altro aspetto, che ne è comunque legato: il legame tra il linguaggio usato dalla politica in questi ultimi anni e il disastro umano e sociale attuale.
Non è un argomento del tutto nuovo, ma forse non è mai stato affrontato in maniera approfondita, almeno dalle nostre parti. In questi ultimi mesi si è parlato molto della disumanità di questo conflitto, di disumanità nei gesti compiuti e che le immagini hanno mostrato in maniera inequivocabile. Si sono viste, infatti, immagini che lasciano attoniti per la loro atrocità e per il dolore che suscitano. E dietro a quelle immagini, che parlano più di milioni di parole, ci sono situazioni reali, concrete, tangibili. Quanto avvenuto nel sud di Israele il 7 ottobre, e quanto è accaduto a Gaza, le cui conseguenze non solo non sono finite, ma sembrano prolungarsi ancora, sono una ferita profonda al senso di umanità, di rispetto della persona. Ho incontrato persone, israeliani e palestinesi, colpite da queste situazioni, arrabbiate, ma profondamente ferite, umiliate, incapaci di comprendere quanto stava accadendo, perdute, ma anche bisognose di parole di vicinanza, di empatia, di comprensione.
Ho capito quanto sia necessario non solo assicurare che i propri uffici facciano la loro parte, ma esserci con una parola di incoraggiamento, ma più ancora di guida e di orientamento, in un contesto che sembra di totale perdizione. Alle immagini di dolore e odio, bisogna rispondere con immagini e parole di speranza e di luce.
Ebbene, non è quello che abbiamo visto nella politica di questi anni, che invece ha abbondato e continua liberamente a spargere parole di odio, di disprezzo, di rifiuto dell’altro. Ministri e autorità politiche da un lato, guide di movimenti e organizzazioni politiche dall’altro, che incitano all’odio, disprezzano il valore della vita umana dell’altro, fomentano e incitano alla violenza non sono stati e non sono tutt’ora un aspetto secondario della compagine politica attuale. E rivestono ancora un ruolo determinante nell’impedire scelte e prospettive politiche di pace e di stabilità. Un politico che sparge ostilità e idee suprematiste, un capo politico che esulta per la morte dell’altro, che prospettive future potranno mai costruire?
Che senso ha parlare di prospettive politiche di pace, di percorsi di riconciliazione, di incontri, di dialogo, di soluzioni politiche definitive, di popoli che sono destinati a rimanere vicini, l’uno accanto all’altro, quale che sia la formula politica, quando a livello locale lo slogan di riferimento è: "Io e nessun altro!" (Is 47,10). E abbiamo visto spesso questo atteggiamento di rifiuto anche nelle tante manifestazioni nel mondo, di una parte o dell’altra.
Ho parlato più volte della necessità di un ricambio nei dirigenti politici. Necessità che deriva da questa costatazione.
Anche le organizzazioni multilaterali, molto indebolite in questo conflitto, sono rimaste spesso ferme e paralizzate sull’impossibilità a trovare un uso concordato delle parole, sul linguaggio da usare.
Bisogna, insomma, avere il coraggio di dire quello che si pensa, ma anche di pensare a quello che si dice, di avere la coscienza che le parole hanno un peso determinante nel formare un pensiero, una cultura, un orientamento. Quanti hanno una responsabilità pubblica hanno il dovere di orientare le loro rispettive comunità con un linguaggio appropriato, che da un lato sia capace di esprimere i sentimenti e la percezione comune, ma dall’altro sia anche capace di orientare il pensiero e, se necessario, limitare la deriva di odio e sfiducia che spesso nei media dilagano con facilità, con parole che sono come frecce che colpiscono al cuore. Non si deve inseguire la corrente, insomma, ma saperla orientare, accettando anche la responsabilità dell’incomprensione e della solitudine. È necessario, in breve, di preservare il senso di umanità, innanzitutto nel proprio linguaggio, in privato e in pubblico, nell’uso dei social media, che hanno un effetto dirompente sull’opinione pubblica, e che allo stesso tempo non consentono di dare profondità e prospettive a situazioni così complesse come quella che stiamo vivendo.
Il linguaggio crea opinione, pensiero, può alimentare speranza, ma anche risentimento. L’umanità, cioè la necessità di rimanere umani, di conservare il senso di rispetto per la dignità della persona, del suo diritto alla vita e alla giustizia, inizia con il linguaggio.
Un linguaggio violento, aggressivo, carico di odio e di disprezzo, di rifiuto e di esclusione non è stato un elemento accessorio a questo conflitto. La deumanizzazione dell’altro, da qualunque parte essa venga, è una forma di violenza che può giustificare scelte di violenza in molti altri contesti e forme.
Se ci pensiamo bene, però, dobbiamo riconoscere che questo fenomeno è iniziato ben prima del 7 ottobre. Quante volte in questi anni bisognava fare attenzione a non usare certe parole in un contesto, che invece erano comuni nell’altro, e viceversa. Ciascuna delle due parti, israeliana e palestinese, aveva un suo vocabolario, una sua narrativa, diversa e indipendente l’una dall’altra. Che non si sono mai incontrate, se non in piccoli circoli ristretti.
È necessario quindi il coraggio di un linguaggio non esclusivo. Che anche nel più duro dei conflitti e delle contrapposizioni, mantenga comunque saldo e chiaro il senso di umanità, perché, per quanto la si possa sfigurare con la propria condotta malvagia, restiamo comunque tutti persone create a immagini di Dio, sempre.
È necessario quindi, nel pubblico e nel privato, nei media, nelle sinagoghe, chiese e moschee, avere il coraggio di parole che aprano orizzonti, e non diano pretesto a violenza e rifiuto. Non è questo, in definitiva, il più grande contributo della Chiesa, nella nostra situazione, fornire cioè un linguaggio in grado di creare un mondo nuovo, non ancora visibile ma che si manifesta all’orizzonte?
Ma anche i centri di cultura come questo rivestono un ruolo centrale nella formazione di un linguaggio, e perciò di un pensiero, che sia rispettoso dei diritti delle persone e delle comunità, che aiuti ad interpretare la realtà, ma anche a costruirla, a creare percorsi di formazione che aiutino a comprendere i grandi cambiamenti in corso, senza subirli passivamente. Una politica che non abbia una visione, un pensiero fondati sul senso comune di umanità e di comune appartenenza, di rispetto della dignità propria ed altrui, può solo portare rovina, come abbiamo visto.
1.3 Il vissuto delle comunità
In questi anni, insomma, le comunità israeliana e palestinese, hanno vissuto un dramma interiore senza precedenti, che ha intaccato in maniera profonda il senso di fiducia in un cambiamento possibile, di un possibile futuro almeno di stabilità politica e di serenità.
Si sta ancora respirando, insomma, un senso di generale depressione, di stanchezza che il cessato il fuoco non è riuscito a rimuovere. La liberazione degli ostaggi ha portato sollievo nella compagine israeliana, ma non ha risolto la crisi politica del Paese, che sembra sempre più diviso sull’idea di identità statuale.
Se all’interno della popolazione israeliana vi è un certo sollievo per la liberazione degli ostaggi, tra la popolazione palestinese la situazione è del tutto opposta. A Gaza tutto è distrutto e non si vede una chiara idea di futuro, sia nella ricostruzione che nella governance futura. In Cisgiordania la situazione continua a deteriorare, con attacchi continui dei coloni, senza alcun rispetto per le leggi e per la vita della popolazione locale. E non si vede all’orizzonte un cambiamento di questo orientamento.
Tutto questo, unito all’orrore del conflitto già accennato, ha acuito sempre di più il senso di sfiducia, di abbandono, di mancanza di speranza. Al contrario, i sentimenti di ostilità e di rifiuto tra israeliani e palestinesi sono sempre più profondi.
Ribadisco: senza una leadership politica e religiosa capace di orientare diversamente le proprie rispettive popolazioni, non si uscirà facilmente.
Dovremo ricostruire tutto. Non solo le case, ma la fiducia. E per farlo, le parole "giustizia", "verità", "perdono" e "riconciliazione" dovranno smettere di essere mere aspirazioni e tornare ad essere esperienze vissute.
Ma come si ricostruisce l’anima di un popolo? Serve un modello. Serve un’idea forza. Ed è qui che la fede smette di essere consolazione privata e diventa chiave di lettura profetica della storia.
Credo che il tempo che ci sta davanti dovrà ora essere dedicato a ricostruire dalla devastazione umana, sociale e religiosa che questo conflitto ha creato. Di analisi politiche le università sono piene, di denunce i tribunali internazionali se ne occupano, di discussioni i parlamenti abbondano.
È necessario, ora, creare le basi e fissare dei criteri per ricostruire, per ridefinire la nostra vocazione ecclesiale. E vorrei farlo usando l’immagine della Gerusalemme dell’Apocalisse, come appare negli ultimi due capitoli. Mi è un’immagine cara, anche perché dopotutto, sono il vescovo di Gerusalemme. E credo che quell’immagine rifletta molto bene quella che deve essere la vocazione della Chiesa oggi, in questo nostro preciso contesto.
2.0 La Vocazione — Il Sogno di Dio Chiamato Gerusalemme
La Bibbia inizia con un giardino, l’Eden. Ma termina con una città: la Gerusalemme nuova. Questo non è un dettaglio. È una rivelazione. Il compimento della storia umana non è un ritorno all’innocenza primordiale, ma l’ingresso in una comunità matura, complessa, riconciliata: una Città.
Gerusalemme, nella visione dell’Apocalisse, non è un’utopia. È un modello di esistenza. È lo stile cristiano di stare nel mondo. Analizziamo insieme i suoi tratti costitutivi, che — ripeto — considero esprimano bene la nostra attuale vocazione come Chiesa di Terra Santa e forse non solo.
2.1 Una Città con il Cielo Aperto (Ap 21,1)
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. (Ap 21,1)
La prima cosa che Giovanni vede non è la città, ma il suo cielo. "Un cielo nuovo". Gerusalemme ha un cielo. Può sembrare scontato, ma non lo è.
La sua antagonista, Babilonia, nella Bibbia è descritta in ogni dettaglio: i suoi fiumi, i suoi deserti, i suoi abissi. Ma di Babilonia non si vede mai il cielo. È una città senza cielo, e quindi senza Dio, chiusa in un orizzonte puramente umano, destinata alla rovina.
Gerusalemme, invece, non solo ha un cielo, ma ha un cielo particolare: è un cielo "nuovo". Perché è nuovo? Non è la prima volta che Giovanni parla di cielo: al capitolo 4, dopo le lettere alle 7 chiese, le visioni si aprono con un annuncio: il veggente vede che una porta è aperta nel cielo (Ap 4,1).
Quindi, il cielo è nuovo fondamentalmente perché è aperto, ed è aperto perché il Figlio dell’uomo è sceso dal cielo e al cielo è ritornato (Cf. Gv 1,51). È nuovo perché, ritornando nei cieli dopo la risurrezione, il Signore glorioso porta con sé l’umanità intera: il cielo nuovo è un cielo già abitato dall’umanità. Dove c’è un cielo nuovo, di conseguenza c’è anche una terra nuova (Ap 21,1) e una città nuova (Ap 21,2).
La Gerusalemme di questa visione dell’Apocalisse è caratterizzata da una totale novità di vita: "le cose di prima sono passate...ecco, io faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5).
È una bellissima descrizione dell’identità di Gerusalemme, e ricorda a noi credenti che per costruire la città, per costruire le relazioni tra noi e tra le nostre comunità si deve partire innanzitutto dalla coscienza della presenza di Dio, dalla fede. Dio non deve essere escluso. Gerusalemme ha un cielo, ha la presenza di Dio. Gerusalemme, dunque, non è solo questione di confini politici, di accordi tecnici. Bisogna prendere coscienza che la caratteristica principale, l’identità della città santa e della Terra Santa in generale, è quella di essere il luogo della rivelazione di Dio, il luogo dove le fedi sono a casa. Molti degli accordi precedenti su Gerusalemme sono falliti e anche i futuri falliranno se non si prenderanno in considerazione le sensibilità religiose e spirituali delle comunità che le appartengono, ebraiche, musulmane e cristiane. Gerusalemme deve essere innanzitutto casa di preghiera per tutte le genti. Abbiamo davvero bisogno di novità, di uscire dai vari Status Quo, di costruire nuovi modelli di vita e di relazioni, dove la comune fede in Dio deve diventare occasione di incontro e non di esclusione, che ci apra al cielo e al mondo, dove tutti i credenti si sentono chiamati a portare l’umanità a Dio.
Nessun progetto di pace nella Terra Santa può prescindere dalla dimensione verticale, dalla coscienza che quella terra è, prima di tutto, il luogo della Rivelazione.
2.2 Una Città che Scende (Ap 21,2.10)
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo... L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. (Ap 21,2.10)
Gerusalemme non si innalza orgogliosa verso il cielo. Scende. E Giovanni la vede scendere due volte. Questo non è un atto unico, è il suo modo di essere. Questo movimento discendente non è qualcosa di accaduto una volta per tutte, ma un modo di essere. È una città che continuamente si riceve da Dio. La sua vita non è una conquista, ma un dono. Giovanni usa le immagini bibliche di sposa che si adorna per lo sposo, e di tenda dove Dio abita. È dunque una città chiamata a vivere una profonda intimità con il Signore, ma anche essere come la tenda biblica, luogo di incontro tra Dio e gli uomini. Nell’abitare di Dio tra i suoi, accade il compimento la vittoria sul male e sulla morte: non solo il male è vinto, ma l’uomo è consolato da Dio stesso, che asciuga le lacrime dai volti (Ap 21,4).
Questo è un monito cruciale per le istituzioni religiose: senza un continuo "discendere dal cielo", senza un attingere umilmente alla fonte della relazione con Dio, la religione rischia atrofizzarsi. Le religioni, senza questo continuo "discendere dal cielo", senza cioè continuamente attingere dalla relazione con Dio il proprio modo di pensare, senza nutrirsi continuamente dalla Parola di Dio, rischiano di diventare fortezze inespugnabili e non città aperte al mondo. Il ricevere continuamente da Dio la forza e lo sguardo, non è dato una volta per tutte, e richiede una continua tensione spirituale.
2.3 Una Città senza Tempio (Ap 21,22)
In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. (Ap 21,22)
Dunque, Dio pensa ad una città dove vivere in mezzo agli uomini. Nell’Antico Testamento questa presenza di Dio era garantita dal tempio, luogo dove Dio abita e dove gli uomini posso accedere per incontrarlo.
A questo proposito, la visione di Gerusalemme dell’Apocalisse presenta una novità importantissima, che è evidente soprattutto dal confronto con il testo a cui Giovanni si riferisce, cioè ai capitoli 40-48 del profeta Ezechiele, che parlano appunto del Tempio come luogo della presenza di Dio. "La città si chiamerà da quel giorno in poi: Là è il Signore" (Ez 48, 35).
Di tutto questo nell’Apocalisse non troviamo nulla. Qui la visione compie un balzo straordinario. "Non vidi alcun tempio". Nella città di Dio, il sacro non è più confinato. Non c’è più distinzione tra sacro e profano. Dio non abita in un edificio, ma nella relazione. "Il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio". Non c’è un luogo dove Dio esiste e un altro no; non c’è un luogo dove Lui ascolta e un altro dove Lui non ascolta. E significa anche che non c’è qualcuno incluso e qualcuno escluso. Tutti sono ammessi, proprio perché non c’è più separazione. In Ezechiele l’ingresso al tempio era possibile solo a sacerdoti, e il tutto era organizzato da una rigidissima classificazione. Nella Gerusalemme nuova, possono entrare tutti: uomini, donne, bambini, liberi e schiavi, sani e malati.
Nella Gerusalemme nuova non ci sono luoghi da possedere, ma solo relazioni da costruire. È una indicazione importante in questo contesto di scontro per il possesso della terra, per la definizione di confini, di esclusione reciproca. Occupare spazi sembra essere la nostra preoccupazione principale. Sembra quasi che per costruire relazioni, per avere una parola da dire, sia necessario avere proprietà, occupare spazi, giustificare la propria presenza con un possedimento. Se non hai un luogo, non sei nessuno. A tutti i livelli: confini, luoghi santi, proprietà... tutto sembra essere costruito sul possesso. Tutto sembra giocarsi a partire dalla questione degli spazi, che sono diventati il criterio unico di interpretazione delle prospettive politiche e sociali. E abbiamo visto a cosa ha portato tutto questo. Forse è necessario ripensare questi criteri.
Non dobbiamo essere naïve. I confini servono. Abbiamo bisogno di definire i propri spazi vitali. Ma non devono diventare causa di divisione. Si deve — e si può — trovare il modo di vivere insieme, rispettando uno i luoghi dell’altro e laddove i luoghi sono condivisi, sapere trovare vie di concordia, nel rispetto della storia e delle diverse sensibilità. Il Dio della nuova Gerusalemme non occupa spazi e non crea barriere. Nessuno è escluso. E non si deve dunque usare Dio, per giustificare le proprie scelte di esclusione.
Non è una lezione da poco, in un momento in cui invece si parla una lingua completamente diversa, dove uno nega l’altro, i suoi luoghi, la sua storia fino anche alla sua presenza, in casi estremi. È una indicazione importante soprattutto in questo periodo. È una rivoluzione copernicana.
2.4 Una Città Illuminata da una Lampada (Ap 21,23)
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. (Ap 21,23). "Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà" (Ap 22,5).
Abbiamo detto che non c’è il tempio; ma allora dove sta Dio, come abita in Gerusalemme? Dove lo si incontra? La presenza di Dio nella città non è una presenza ingombrante, voluminosa, non occupa spazio, non si fa notare per la sua grandiosità, non si impone.
Dio nella città è presente come una lampada, come una luce. È presente come un nuovo modo di vedere, e quindi un nuovo modo di vivere, illumina le relazioni, la vita, tutte le cose.
Dio è una luce pasquale che permette di vedere la vita anche laddove i nostri occhi vedono solo morte. Ci invita a ripensare il futuro della Città al di là del criterio unico del possesso degli spazi, dei confini, della proprietà. Dobbiamo uscire da questa prospettiva claustrofobica. La luce non la si possiede, la si accoglie e la si diffonde.
2.5 Una Città dalle Porte Sempre Aperte (Ap 21,25)
*È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele... Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. (Ap 21,12-14)*
Una cosa ci stupisce per la sua incongruenza, come se vi fosse un errore sotto l’aspetto cronologico. Gli apostoli vengono posti a fondamento dell’edificio, ne sono il basamento; mentre le porte - che abitualmente nella costruzione di un edificio vengono dopo - sono rappresentate dalle dodici tribù d’Israele. Nel percorso della salvezza le tribù d’Israele vengono ben prima dei dodici apostoli, e sarebbe più logico che fossero messe come fondamento, e non come porte! Questa è la singolarità e la novità di questa costruzione: nel progetto di Dio, non necessariamente ciò è più antico rimane come fondamento. Dio ricrea la storia ponendovi fondamenta nuove, che permettono una nuova realtà. Ma nulla viene scartato o perduto, tutto è necessario e tutto ritrova il proprio posto dentro un edificio nuovo. Così Gerusalemme diventa il compimento sia per le dodici tribù sia per i dodici apostoli, e solo all’interno di essa ciascuno può ritrovare il suo senso e la sua missione.
È un argomento importante: la lettura della storia. Ciascuno oggi ha la propria lettura della storia, la propria narrazione degli eventi, spesso costruita in una visione che considera l’altro come colui dal quale ci si è dovuti difendere. A volte a torto, a volte a ragione. È necessario un ripensamento delle categorie della storia, della memoria, e di conseguenza anche della colpa, della giustizia, del perdono, le quali pongono a contatto direttamente la sfera religiosa con quella morale, sociale e politica. Gran parte delle cause per la violenza di oggi sta nell’incapacità di elaborare (nel linguaggio religioso si direbbe: redimere) la propria narrativa storica. Lo vediamo anche nell’uso delle varie terminologie, i nomi dati ai luoghi, che raccontano la storia di quei luoghi in modalità completamente diverse. Resteremo sempre bloccati, senza una rilettura della propria storia. Senza negare nulla ai fatti del passato, ma senza che questi determinino le scelte di oggi.
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. (Ap 21,25)
Le mura di una città sono costruita a difesa. Qui invece non sono costruire per difendere nulla. Servono per definire chi vuole vivere nello stile della Gerusalemme nuova, alla luce dell’agnello e chi no. Non c’è nulla da difendere, ma solo uno stile da proporre. "La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli" (Is 56,7).
Le porte sono aperte nelle quattro direzioni, perché chiunque, in qualsiasi momento, possa entrarvi e far parte di questa realtà nuova in cui si vive una vita nuova, possibile a tutti, nessuno escluso.
Ciò che nella prima alleanza era privilegio di un solo popolo, ora è esteso a tutti: tutti possono far parte del popolo santo di Dio. È un’altra chiara indicazione. Non vi può essere un monopolio di qualcuno. La pace non si impone. Non è frutto dell’imposizione di qualcuno, ma della condivisione di un comune progetto, dove tutti sono parte integrante.
2.6 Una Città che Guarisce le Nazioni (Ap 22,1-2)
Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore... E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. (Ap 21,24.26)
Non solo i popoli non rappresentano alcuna minaccia, ma al contrario, sono considerati una ricchezza. Questa è un’altra delle grandi novità. È la loro presenza a fare la bellezza di Gerusalemme! Sono così completamente invertiti i canoni della bellezza, della santità, della purità: non è ciò che è incontaminato, solitario, isolato ad essere bello, ma ciò che è aperto all’altro è simbolo di bellezza. Gerusalemme è ricca di ciò che accoglie.
All’inizio abbiamo visto che Gerusalemme si costruisce tanto quanto si riceve da Dio; ora la visione si completa, e possiamo costatare che Gerusalemme si arricchisce tanto quanto si riceve dagli altri. Le due cose vanno insieme.
Sembra la realizzazione della profezia di Isaia: "Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri» (Isaia 2,2-3).
La Terra Santa non è un microcosmo chiuso in se stesso. Ha un legame indissolubile con tutto il mondo, e viceversa. Anche per questo oggi siamo qui a parlare di Terra Santa, per questa vicinanza storica, culturale e religiosa con quanto accade in Terra Santa, la terra testimone della storia della rivelazione, e paradigma delle dinamiche che coinvolgono tutto il mondo. Il cuore del mondo batte a Gerusalemme. Lo testimoniano i milioni di pellegrini che giungono da tutto il mondo nella città santa. I pellegrini sono parte dell’identità della città. Senza di essi, la città è incompleta, e lo vediamo purtroppo molto bene in questi giorni.
I governanti locali dovranno sempre tenere in considerazione che quanto è vissuto a Gerusalemme, coinvolge la vita di miliardi di credenti in tutto il mondo. Non è solo affare privato di chi ha la grazia di vivere in quei luoghi. E il mondo ha il dovere e il diritto di interessarsi e anche di intervenire. Gerusalemme è di tutti e nessuno potrà averne il monopolio esclusivo.
Un fiume d’acqua viva
*E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni. (Ap 22,1-2)*
La vocazione di Gerusalemme non è chiusa dentro le proprie mura, non si esaurisce dentro di sé: sarebbe troppo poco se Gerusalemme fosse "solo" tutto quello che abbiamo detto finora. Dal suo cuore, lì dove regna l’Agnello, scaturisce una sorgente di acqua viva che permette la crescita di un albero di vita, non solo per sé, ma anche per tutto il mondo.
Gerusalemme è una città in uscita, una città chiamata a portare frutti per l’umanità. Ha una missione specifica, che è solo sua, quella di "guarire le nazioni". Guarire da cosa? Il testo non lo dice. Dice però che ciò che guarisce è il suo essere viva, il suo partecipare alla vita di Dio.
Di guarigione avrà bisogno la Terra Santa. Serviranno lunghi percorsi di guarigione delle tantissime e dolorosissime ferite che questo conflitto ha prodotto nella vita di tutte le comunità.
Guarigione dalle ferite, dall’odio, dalla memoria tossica. È questo il suo compito ultimo e sublime.
3.0 Conclusione: Dal Simbolo alla Storia
Mancano nella mia presentazione molti altri passaggi, naturalmente. Mancano soprattutto i passaggi di castigo verso chi rifiuta quella visione e decide di starne fuori.
Ma ho voluto fermarmi soprattutto a quella che considero una buona immagine, un’ispirazione per la comunità cristiana di Gerusalemme, per quella che deve essere la sua vocazione in questo momento storico.
Abbiamo bisogno, infatti, di avere un riferimento ideale al quale richiamarci e al quale ispirarci per la nostra riflessione. Ciascuno dei passaggi che ho riportato, infatti, può avere anche immediati richiami politici. L’identità religiosa di Gerusalemme, tuttavia, è un richiamo a non presumere di risolvere i problemi della Terra Santa solo ed esclusivamente dentro un contesto politico. I fallimenti del passato hanno ampiamente dimostrato della necessità di tenere in conto le varie sensibilità religiose.
Tenda e Sposa sono immagini belle che parlano di intimità e di comunione. Le varie comunità di Gerusalemme — ebrei, musulmani e cristiani — costituiscono insieme l’identità della città. L’intimità con Dio va insieme all’armonia tra le comunità. Barriere e divisioni tra le comunità, sono una negazione dell’intimità di ciascuno con Dio. È dovere quindi dei responsabili politici e religiosi favorire una sempre maggiore relazione tra le varie comunità, che purtroppo non si conoscono bene le une le altre.
Le istituzioni religiose se non custodiscono la loro dimensione religiosa, diventano istituzioni bloccate, ingessate, che anziché fare crescere nella fede, diventano l’ostacolo ad una retta conoscenza di Dio.
La presenza dell’agnello che è fonte di luce, indica anche uno degli elementi più dolorosi di questo conflitto e dei precedenti: i confini, la terra, le proprietà, i Luoghi Santi... Il testo biblico invece ignora questo aspetto. Si dovranno quindi trovare equilibri nuovi, dove le proprietà, i Luoghi Santi e i confini non sono un assoluto intoccabile. La storia e il conflitto attuale ha dimostrato dolorosamente il suo fallimento su questo argomento. Si dovrà quindi cercare di individuare soluzioni che tengano presente la realtà del territorio e delle esigenze vitali di ciascuna comunità, ma in modalità diverse rispetto al passato.
Non si potrà fare tutto questo senza una seria rilettura della storia e un ripensamento delle categorie di memoria, e di conseguenza, senza percorsi di guarigione, di perdono.
Non ci si potrà illudere di trovare soluzioni da soli. Gerusalemme è di tutti, perché tutti la sono nati (Sl 87,4). E in questo contesto la comunità internazionale è chiamata a fare la sua parte, più di quanto sia stata in grado di fare fino ad ora.
Abbiamo ora bisogno di ritrovarci come comunità, di riprendere le relazioni con ebrei e musulmani. Avremo bisogno anche di nuova leadership, ma ci sarà bisogno soprattutto di un nuovo linguaggio, di nuove prospettive, qualcosa di diverso su cui costruire le relazioni del futuro. Non si potrà fare tutto, ma ci servirà comunque un riferimento ideale al quale richiamarci e con il quale poco alla volta, passo dopo passo, nei tempi che saranno certamente lunghi, rimodellare le nostre relazioni.
Dio con la Parola ha creato il mondo. Noi creiamo il nostro con le nostre parole.
Sarà questa la missione della Chiesa di Gerusalemme. Ripartire da questa immagine potente. La comunità cristiana di Gerusalemme, piccola ma resiliente, è chiamata a vivere qui e ora, nella realtà drammatica del conflitto, lo stile della Gerusalemme celeste.
Essere ponte, non barriera. Essere luce pasquale, che illumina le tenebre del rancore. Essere casa dalle porte aperte, dove l’altro è accolto come dono, non temuto come minaccia. Essere strumento di guarigione, che non si stanca di curare le ferite.
Gerusalemme, la città terrena, con le sue ferite, è chiamata a diventare sempre di più un segno, un sacramento di quella Gerusalemme che scende da Dio, ricca di pace, aperta a tutti, e il cui unico scopo è guarire il mondo.
Grazie.